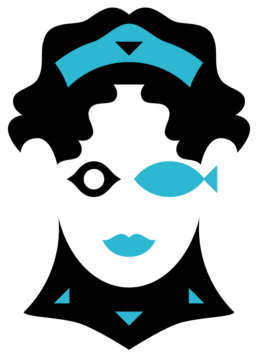Con gli occhi delle bambine
Atlante dell’infanzia a rischio 2020
Circa dieci anni fa in Egitto, in una sperduta comunità, conobbi una bambina di dieci anni che mi lasciò senza parole. Si era alzata in piedi per raccontare, a me e agli altri colleghi di Save the Children, cosa avesse fatto per lei il programma di educazione che portavamo avanti nella sua comunità. Le aveva permesso di non essere infibulata. Amal – questo il suo nome – aveva scoperto di avere dei diritti e una voce per farli rispettare. Aveva capito di poter pretendere un futuro migliore e aveva convinto la madre e la nonna a non sottoporla a quella pratica brutale, che affonda le sue radici in una tradizione talmente solida e radicata che i genitori la danno per scontata. Mi disse anche che la sua “missione”, a quel punto, era raggiungere lo stesso risultato per la sorella minore. Ricordo di aver ascoltato Amal con un misto di ammirazione e soddisfazione. Ammirazione per quella piccola leader che non aveva avuto paura di lottare con caparbia determinazione. E soddisfazione per aver contribuito con il nostro programma a quel risultato. Dieci anni dopo, in questo 2020 così difficile, nel nostro Punto Luce di Torre Maura a Roma, ho conosciuto una ragazza di origine somala, nata in Italia. Alla domanda “cosa stai imparando qui”, lei con convinzione ha risposto: “Ad essere una cittadina attiva, ad esercitare il mio diritto di partecipare alla vita del Paese e a lavorare per cambiare ciò che non mi piace”. In quel momento, in un altro punto del mappamondo, a distanza di tanto tempo, ho provato gli stessi sentimenti di ammirazione e di soddisfazione di allora. Leggere questo Atlante, dedicato alle bambine e alle ragazze, aiuta a mettere nella giusta prospettiva le esperienze che ho, sin qui, raccontato. I dati e le analisi che si snodano nelle pagine a seguire tracciano un percorso impegnativo, ricco di ostacoli, sfide, problemi per le ragazze. Ma danno anche evidenza della loro capacità di resilienza, del loro saper fare di più anche con meno risorse e della loro spinta a proiettarsi verso l’esterno, ad impegnarsi nella vita pubblica, con una lettura della realtà attenta e consapevole.
nota dell'autore
Questi sono i suoni, gli odori, i colori, i sapori e profumi della nostra terra, quella stessa che ha generato, concimato, germogliato le storie di ordinaria straordinarietà dei nostri titani e titanidi.
nota
dell'autore
azzurro cielo
giallo oro
verde smeraldo
blu balena
blu avion
Un libro è come un vortice che ti travolge. Ti travolge rigo dopo rigo quando lo leggi. Parola dopo parola quando lo scrivi. Virgola dopo virgola. Punto dopo punto. Questa breve nota non vuole anticipare nulla di questo volume; ogni capitolo è già sufficiente a spiegare quanto desidera; ogni pagina ha il potere di esprimere il suo intento senza che queste righe possano aggiungere molto altro.
E allora perché questa nota?
Perché se ogni singolo foglio sarà in grado di travolgervi, a volte di avvolgervi, con una stretta quasi fisica, stritolante e massiccia, tanto da sentirne quasi l’odore, il sudore, queste poche righe contenute in questa breve nota vogliono restituirvi il sapore, i profumi, il colore, il calore, l’odore e i suoni di queste pagine.
Il sapore tutto partenopeo delle butteglie e pummarole appena fatte. Il colore del ciano intenso che va dall’azzurro cielo terso della costiera frastagliato di limoni giallo oro, al verde smeraldo dei suoi anfratti marini; dal blu balena dei fondali alla notte tra Amalfi e Positano, al blu avion del mare a perdita d’occhio, all’orizzonte, al tramonto, in uno dei pomeriggi in giro per la Divina. E ancora il celeste acquamarina, dei segni d’acqua, i verdi intensi della natura, dei suoi spazi aperti e l’arancio energico, giallo sole della forza propulsiva dei raggi che illuminano questo angolo di mondo. I colori cangianti dei passaggi montani, quasi impressionistici, che sbucano, chilometro dopo chilometro, nell’entroterra costiero, come paesaggi di Van Gogh, o come nature morte di Carotenuto, interrotte da segni geometrici e illusioni ottiche, segni indelebili di quella tradizione artistica tipica della ceramica vietrese, delle opere artistiche del Lista, del Dalisi e del Franchini, interpreti fedeli e devoti delle nostre terre.
Il calore delle genti che gesticolano animate e distratte, spensierate quasi a voler sfuggire o rifuggire dai loro attimi, dai loro giorni, dalle proprie croci, a ritmo incalzante, come nelle sinfonie di Beethoven, o adagio come nelle religiose opere sacre, degli inni e dei preludi corali di Bach, o ancora delle melodie sincopate di Mozart. Ogni singola pagina sembra aleggiare sulle note eteree delle arpe e dei violini, correndo e rotolandosi su tutti gli ottantotto tasti del pianoforte, e in un attimo, la metamorfosi, dalle note conosciute e rassicuranti dei grandi classici, a quelle più ruvide e stonate del blues e del jazz, di quello neomelodico, degli albori del grande Pino, nostro indiscusso oracolo. Pino, un Caronte che ha saputo traghettarci nel mondo, facendoci scoprire le più anonime strade della nostra terra, di quella Napule è na’ carta sporca e nisciuno se ne importa. Ma il suono di queste pagine si evolve anche nelle note concitate dell’entroterra più ruvido, meno battuto, a cui ci riportano le note di Vinicio, definito spesso onnivoro gourmet della canzone, canzoniere straripante e universale. Tedesco di nascita, irpino d’origine ed emiliano d’adozione, Capossela ha fatto del randagismo una filosofia di vita; e sembra proprio che sulle note dei suoi brani si adagino le storie di molti dei titani e delle titanesse, contenute in questo volume, migranti a loro modo da una sponda all’altra, nella turbolenta traversata tra follia e normalità.
Questi sono i suoni, gli odori, i colori, i sapori e profumi della nostra terra, quella stessa che ha generato, concimato, germogliato le storie di ordinaria straordinarietà dei nostri titani e titanidi, persone che, ognuna a suo modo, hanno iniziato un viaggio, a volte terminato troppo presto, a volte deviato, spesso ancora in essere, fatto di avventure e disavventure, pur sempre però proteso a celebrare quel qui ed ora che permette di non pensare al futuro, di non ripensare al passato, ma pesare il presente.
È a tutti loro, indiscussi protagonisti di quel Tartaro spesso dimenticato che è dedicato ogni singola parola di questo volume; persone che contano, che si fanno sentire, a volte di meno, ma che sono un segno concreto e scintillante che le storie di ordinaria straordinarietà, e anche quelle di straordinaria ordinarietà esistono e fanno bene. Fanno bene al cuore.Giuliana Saccà
l’autore
celeste acquamarina
verdi intensi
arancio
energico
colori
cangianti
io sono un titano
Introduzione
Ogni storia comincia
con un primo passo.
introduzione
coraggio
forza
splendore
ineluttabilità
incorruttibilità
saggezza
Luna, Tommaso, Lucia, Filippo, Elsa, Remo, Lara, Cristian, Sara, Vincenzo, Ginevra e Leonardo.
Sono loro i veri titani.
In trent’anni ne ho conosciuti di uomini e donne, titani e titanidi, con il coraggio di Rea e la forza di Crio, dallo splendore indiscusso di Teia e dall’ineluttabilità di Giapeto, con l’incorruttibilità di Mnemosine e la saggezza di Ceo, la forza generatrice di Teti e la fermezza di Crono, con i principi di Temi e la potenza vigorosa di Oceano, dall’energia ispiratrice di Febe fino alla diligente attenzione di Iperione.
Ne ho conosciute di Mnemosine, capaci di combattere l’oblio col potere della memoria, di Iperione, cauti e attenti, capaci di vigilare e proteggere, di Crono, in grado di fare del tempo il motore del lento incedere della vita, di Rea, consapevoli e coraggiosi nelle lotte e nelle scelte, e di Giapeto con fragili ma indefesse speranze, umanizzate nell’impegno e nelle mani di chi ci prova nonostante tutto; di Ceo, pazienti e vigorosi, pronti al perdono dopo l’ira. Ne ho conosciuti di Oceano, pronti ad attraversare e rendere fertili le periferie del cuore, di Febe maestri nell’ascolto e nella responsività, e di Teia, guide affidabili
e fiduciose, disposte a fare e concedere uno spazio all’altro, di Teti inesauste curatrici della vita alla ricerca del più esile squarcio di luce, di Temi resilienti ed energiche, capaci di superare le avversità e di uscirne più forti, esibendo le proprie cicatrici e di Crio, inarrestabili ed adattabili, mai rinunciatari di fronte alle salite, alle fatiche e ai dolori.
Ne ho conosciuti di titani e titanidi, anzi titanesse, esempi indiscussi, di un’indiscutibile energia generativa.
Non sono eroi. Sono uomini e donne di ordinaria straordinarietà, che mi hanno dato più di quanto avessi mai creduto di poter donare io loro.
Persone, migliaia di persone, quelle stesse che nessuno immaginava potessero dare inizio e vitalità alle strade percorse, confermare propositi portando avanti anni di vita vera, e che poi sono riuscite a fare battere i cuori e a sprigionare amore, laddove alcuno avrebbe mai potuto immaginare.
A loro, ad ognuno di loro è dedicata ogni singola parola, ogni virgola di questo volume.
E a voi tutti, che vi immergerete in queste pagine dai passaggi lievi e brucianti, fragili e robusti, voglio dire che senza questi guerrieri la battaglia che iniziai, giovane e pieno di sogni, deciso e disorientato, incredulo e tenace, non sarebbe giunta al suo trentesimo anno.
È la loro forza primordiale, il loro sforzo costante, la loro tensione verso l’alto, verso il meglio, verso il cielo, ad aver ispirato ogni singolo giorno di questa storia, anch’essa di ordinaria straordinarietà. Questo, tutto questo è Gea, una realtà che da trent’anni non ha mai smesso di essere al fianco delle persone, attraverso i suoi tanti progetti di assistenza, di accoglienza e di inclusione.
Dall’assistenza domiciliare, il più storico dei nostri servizi, che ci ha permesso di stare accanto a migliaia di anziani, ai centri diurni, specie quelli dedicati agli esordi psicotici, ai disabili e agli emarginati. Dall’assistenza scolastica agli asili nido, dai servizi residenziali a quelli per la comunità, uno tra tutti la ristorazione, ormai divenuto nostro fiore all’occhiello. E ancora l’accompagnamento genitoriale, in particolare per i delicati processi di affido, di adozione e di supporto alla crescita e allo sviluppo. I centri polifunzionali e i progetti formativi, l’orientamento professionale, l’inserimento e il reinserimento lavorativo, grazie a cui siamo riusciti a integrare costantemente giovani, e diversamente giovani, nel tessuto connettivo del nostro territorio.
Un progetto, questo di Gea, che ha dimostrato la sostenibilità di un’idea diversa di stare e restare su un territorio, nei decenni vessato da problemi sociali, in cui le soluzioni, spesso non sembrano a portata di mano, ma che basta lo sforzo di una mano che incrocia un’altra, e un’altra ancora, per riuscire a realizzare l’impossibile. Ogni storia comincia con un primo passo, diceva qualcuno, e aggiungerei, che continua se si ha il coraggio di non contarli, di non farsi opprimere dalla stanchezza, dalle fisiologiche delusioni, dai naturali fallimenti, dagli imprescindibili sbagli. È per questo che abbiamo scelto di parlare di titani, e non di eroi, o di dei, per fare un omaggio della cultura dell’errore, in una società che sembra urlare solo al successo, non insegnando che accettare non significa soccombere, cadere non significa arrestarsi e perire. L’errore di questi uomini e donne non è prudente, non è calcolato, è radice e frutto del loro amore, degli occhi che non li hanno esclusi, delle mani che li hanno accolti, delle braccia che non si sono tirate indietro, dei piedi che li hanno accompagnati. È l’errore che può capitare di vivere quando si realizza il bene, quando ci si sporca le mani e ci si avvicina per fare comunità.
Questo è Gea. Trent’anni di storie di ordinaria straordinarietà.
forza generatrice
fermezza
principi
potenza
energia
io sono un titano
Storia di Leonardo
FRANCO ARMINIO
Punta sulle nuvole sugli alberi e su altre cose mute, non tue, non vicine, non addestrate a compiacerti, punta sulla luce, cercala sempre, infine punta sulla tua follia, se ce l’hai, se non te l’hanno rubata da piccolo.
Storia
di
Leonardo
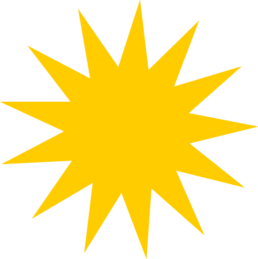
Anche se è notte l’oscurità non è mai totale. Leonardo continuava a ripetersi nella mente questa e nove altre frasi utili che il suo maestro di fotografia, gli aveva raccomandato durante le lezioni del sabato. Non era facile in città cercare luoghi panoramici non sconvolti dall’inquinamento luminoso, eppure anche quella sera era uscito con la sua reflex nera, lunghezza focale 18-55 mm, alla ricerca dello scatto che emoziona.
Evita le sorgenti di luce chiara vicino al tuo obiettivo; tieni in considerazione i giochi di luce che vuoi ci siano nello scatto; evita le funzioni automatiche; imposta tutto manualmente, si diceva, parlando tra sé e sé, e poi c’era altro di sicuro. Come era fastidioso non ricordare bene, e tutto.
L’amore per la fotografia era l’eredità lasciatagli da mamma Raffaella sedici anni prima, insieme ad una casetta di ottanta metri quadri da dividere insieme alla nonna Ninetta e ai suoi tre gatti; anche da lei scappava Leonardo quando usciva la sera e tornava tardi, a passeggiare per quei sentieri, che aveva percorso da bambino.
Raffaella non aveva avuto di certo una macchina fotografica così, che invece Leonardo si era potuto permettere dal momento che a ventisei anni lavora già da poco più di sette, ma era grazie a lei che un maschietto vivace e smilzo, aveva affinato il gusto per la bellezza della montagna e la sensibilità per la fotografia paesaggistica. Raffaella amava raccontargli con tante brevi storie serali che la passione per i processi meccanici ed ottici, lui, il suo adorato Leonardo l’aveva avuta in dono dal padre; ma col tempo, dopo la sua morte, complice anche Ninetta, che poco aveva amato quell’uomo alto, bellissimo e scostante, che entrava e usciva di prigione, Leonardo, aveva a sue spese imparato che quei racconti tanto perfetti e appaganti erano il frutto di un abbellimento voluto, delle vicende della sua famiglia, e che il suo papà non era fuori per reportage e premi, e che quando tornava a casa non era stanco ed insofferente per le numerose persone incontrate nei suoi documentari, come mamma Raffaella gli aveva raccontato. Anche qui non tutti i pensieri erano nitidi; a Leonardo sembrava di perdere enormi pezzi di vita; c’erano giorni in cui, scena dopo scena, i ricordi e le immagini nella sua testa, si confondevano tra un decennio e l’altro di vita. La sua autosufficienza non è in discussione, ma un percorso di riabilitazione è necessario perché le sue abilità cognitive e sensoriali rimarranno in parte compromesse, aveva sentenziato il medico, un giorno. Leonardo, infatti, non lavorava più vicino all’ultima fresa ad alta velocità, dotata di eliche a 45°, capace di alte prestazioni sulle leghe di alluminio e materiali teneri. Una mattina aveva perso conoscenza dopo una spaventosa caduta da quattro metri, che aveva lasciato immobile lui e il povero Tito che lo aveva per primo assistito. La telefonata al 118, meno precisa e più emotiva di quello che gli avevano insegnato al corso di primo intervento, fatto in azienda nove mesi prima. Più volte l’operatrice era stata costretta a chiedergli con un tono risoluto ma caloroso, dove era avvenuto con esattezza l’incidente: il comune, la via e il numero civico. Tito continuava a ripetere la via in cui si trovava, ma non il nome del comune in cui i due lavoravano da più di cinque anni. L’operatrice con voce cadenzata, andava avanti nella sua ricerca di informazioni utili, ricordando un paio di volte a Tito di mantenere la calma e la concentrazione. Una volta che tutte le informazioni furono raccolte finalmente Tito si sentì dire: l’equipaggio di un’ambulanza medicalizzata è stato allertato e arriverà al vostro indirizzo in pochi minuti. L’ambulanza entrò.
Il suo arrivo fu effettivamente rapido, si trovò a pensare Tito, e al telefono con animo ancora concitato, ma più sollevato urlò che erano arrivati i soccorsi. Rimise giù in tutta fretta e solo dopo si accorse di non avere nemmeno ringraziato quella persona, che come lui quella mattina stava facendo il suo dovere e lo stava facendo bene. Leonardo all’arrivo di due soccorritori, un infermiere e un medico, era nuovamente cosciente, non si riusciva a muovere e pronunciava parole inappropriate e confuse, il che poteva sembrare ilare, se non fosse che questi comportamenti spaventarono da subito, anche Tito e tutti i non addetti ai lavori che, comprensibilmente, si erano radunati ad una certa distanza. Seguirono giorni con esami diagnostici ogni sei ore e controlli neurologici, farmaci e terapia intensiva. Alla fine Leonardo uscì dall’ospedale con le sue gambe, un ruoto di torta rustica preparato dalla moglie di Tito e una diagnosi di contusione cerebrale. Nei mesi successivi e per gli anni avvenire le emiparesi trattate in ospedale sarebbero perdurate, ma non si facevano notare molto; più fastidiose apparivano le crisi epilettiche parziali, che lo colpivano a tradimento e le amnesie retrograde, che non gli permettevano di ricordare con lucidità gli eventi precedenti all’incidente. Iniziò a frequentare il centro di Tramonti, che lo aiutava nella gestione delle crisi di rabbia e nella somministrazione della terapia farmacologica per tenere a bada l’epilessia. Il laboratorio di canto era il suo preferito, il maestro gli faceva continui complimenti per la sua estensione vocale e la frequentazione delle ore insieme agli altri degenti canterini alleggeriva e colorava di buon umore le sue mezze giornate, prima di tornare a casa da sua nonna e dalla sua reflex. A lui spettava ancora occuparsi di lei, dal fare la spesa al preparare la cena, e sebbene in alcune stagioni dell’anno fosse più difficile e fisicamente faticoso per lui, era fondamentale coccolare quella parte sana di famiglia che gli era rimasta. Il suo lavoro in officina era andato, le produzioni con la macchina fotografica erano risultate meno precise per i tremori alle mani; di pomeriggio si sentiva fiaccato e per poco meno di un anno soffrì di episodi depressivi, mangiava in maniera disordinata e saltuaria, non si lavava, stava a letto tutto il giorno. Erminio, però, il terapista occupazionale del Centro lo ancorò senza mai allentare la presa. Nei momenti più bui continuò a spronarlo e ad incoraggiarlo, e come il picchio rosso mezzano nelle foreste ad alto fusto, tambureggiava e supervisionava sulla volontà e sui progetti di Leonardo, più di qualche volta pronto
a mollare, con protocolli e ammonimenti da vero life coach.
Le attività di riabilitazione post-traumatica diminuirono al crescere della padronanza emotiva e fisica di Leonardo che, grazie al lavoro e alla cura delle persone del Centro, non permise agli eventi di ridimensionare la gioia di passeggiare ed osservare la natura, insistendo a ricostruire il suo progetto di vita, focalizzandosi non solo sulla riabilitazione, ma anche e soprattutto, sulla rieducazione sociale e lavorativa e supportando il maestro di canto con i nuovi pazienti. Come il titano Iperione, personificazione del sole, così anche Leonardo celebra il fluire della luce nelle metamorfosi della vita, che sommano l’illuminazione di un presente vissuto all’illuminazione altra di un presente successivo. Nonna Ninetta continua la sua vita partecipe dei ricordi di Leonardo e ignara beneficiaria delle cure di quel nipote che, nell’accudirla, non smarrisce la sua umanità di fronte alle fatiche e alla brutalità della vita e ritrova uno scopo diverso e complementare a quanto aveva immaginato per i suoi ventotto anni, amare chi ti ha amato e capovolgendo i ruoli, vigilare sugli orditi dei sentimenti familiari, entrambe fotografie senza tempo, ma con una meta in comune: l’amore offerto e l’amore custodito. Lo spirito di Iperione, che come ci tramanda la mitologia, fu il primo a capire, con diligente attenzione e osservazione, il movimento sia del Sole che della Luna e delle altre stelle, abita nell’agire insistente di Leonardo, che vive le tante notti oscure alla ricerca di quella fonte di illuminazione di Colui che sta in alto. È proprio cadendo da tanto in alto che Leonardo ha capito quanto in alto si possa guardare.

io sono Iperione
Storia di Ginevra
EMILY DICKINSON
L’acqua è segnata dalla sete. La terra, dagli oceani traversati. La gioia, dal dolore. La pace, dai racconti di battaglia. L’amore da un’impronta di memoria. Gli uccelli, dalla neve.
Storia
di
Ginevra

Qualche passo ancora, nonna. Sei quasi arrivata! Dai, brava così. Inconfondibile e squillante la voce di Gioia, elettrizzata e galvanizzante, come quella di ogni bambino pronto alla gita domenicale, inondava il silenzio di quella collina soleggiata e fino a quel momento silenziosa. La scelta della meta nel mese di maggio era caduta sul Castello di Mercato San Severino.
Nonna e nipote iniziarono la loro passeggiata attraverso la storia ed il tempo. Attraversarono accaldate ed emozionate quella che secoli prima era stata la cosiddetta Piazza d’Armi per le parate militari nell’anno 1000, oggi estensione di verde primaverile, con qualche macchia di fiorellini lilla qua e là e due gatti sornioni, che riposavano al sole.
La voce di Gioia riferiva con toni energici, quanto aveva imparato a scuola con la maestra; per nulla doma proseguiva a raccontare della grande grata che veniva calata per chiudere e proteggere l’ingresso del castello, della cisterna che più di mille anni dopo, adempiva al suo compito di raccolta dell’acqua, delle finestre, antichi squarci nella roccia, dai quali i soldati scrutavano i movimenti di potenziali nemici.
Ciò che la entusiasmava di più, però, era la cappella, dove un tempo era passato anche Tommaso d’Aquino e per lei, con una mamma nata e cresciuta a Fornace, piccola frazione della città del Santo, con soli ventidue abitanti, era una sicura occasione di vanto. Meno di un’oretta di passeggiata piacevole, su e giù per i gradoni di pietra, tra i ciuffi di erba cresciuti in maniera omogenea nei secoli, il primo sole che riscaldava viso e spalle dopo un inverno piovoso, ed eccole arrivate all’area picnic, che accoglie le risa festose degli ospiti del Castello. Gioia continua a parlare e raccontare agli avventori al loro stesso tavolo di cavalieri, reliquie e Longobardi e la nonna la guarda ammirata e ad un tratto improvvisamente assalita da un mix di sentimenti, come da anni non le succedeva più. Le si fanno incontro emozioni contrastanti, pensieri confusi e un po’ tristi misti a imprecisi sensazioni di pace. La combinazione di suoni e odori di quel paesaggio e l’incanto per la vitalità di questa nipotina, la riportano indietro nel tempo, ad una fotografia di molti anni prima, quando in quello stesso luogo, in un’ala del castello, a tenere la mano, di sua figlia Ginevra, una bambina di quarta elementare, vivace ed affettuosa, al suo posto c’era la maestra Pupetta, una minuta signora, dai capelli bianchi con un sorriso contagioso. Ginevra, la mamma di Gioia, era stata una bimba con vissuti di inadeguatezza, scarsa fiducia nelle proprie possibilità, incomprensioni scolastiche e attriti in famiglia per la sua poca organizzazione e scarsa autonomia nello studio, per quegli errori di comprensione e di accuratezza nel leggere e scrivere.
Il momento dei compiti era divenuto da subito un momento spaventoso e di avvilimento per tutti i protagonisti; e le ripercussioni sull’ambiente familiare erano arrivate subito dopo. Mamma e papà litigavano ogni sera per quella bimba che non si applicava e poteva dare di più, perché non era certo stupida, urlava stanca e afflitta la mamma al papà, che non comprendeva come fare i compiti potesse diventare un periodo così penoso.
I primi due anni di scuola primaria erano stati faticosi e dolorosi sia per Gilda che per Ginevra, pieni di incomprensioni e frasi del tipo: dopo averle spiegato cosa deve fare, resta seduta con sguardo fisso a guardare il foglio; o ancora: non è per niente motivata e niente la motiva!
Espressioni dure come queste Ginevra se ne era sentite dire tante e per tanto tempo, da insegnanti non ancora allenati a tradurre i sintomi di un disagio scolastico, genitori impreparati e maestri del dopo scuola non formati, restando pensierosa ad osservare adulti, che mostravano grandi difficoltà a capire i suoi mutismi, i suoi problemi di condotta e ascoltare le parole sulla sua continua stanchezza. La maestra Pupetta ebbe il merito di osservare con amore, di chiedere il supporto di un dirigente scolastico attento, che attivò i canali del sociale e di spiegare ed interpretare con pazienza alla famiglia quei comportamenti che erano stati per lei, segnali di un disagio, per tutti gli altri, sofferenza e giudizio. Con semplici provvedimenti di modifica della didattica e momenti dedicati alla valutazione orientati al bambino, oggi diventati cardini delle linee guida nazionali per tali disturbi, la maestra accolse e diede una restituzione alla paura di Ginevra e alla frustrazione della sua mamma. Come ebbe a dire anche la neuropsichiatra infantile al centro, tra i primi sorti trent’anni fa, che Ginevra frequentò dalla quarta elementare in poi, per recuperare competenze e maggiore stima in se stessa, i bambini e le bambine con un qualche disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) non possono da soli o con la sola forza di volontà crearsi l’opportunità di sforzarsi di più ed attivare una maggiore attenzione al compito, perché non si tratta di volontà o impegno, di motivazione o proattività; il loro è un disturbo di origine biologica ed hanno necessariamente bisogno di chiedere e ricevere aiuto per fare ognuna di queste cose. Come un oracolo provvidenziale questi dettami scandirono allenamenti ed esercitazioni a scuola, a casa e al Centro per molti anni della vita di Ginevra e di altri bambini come lei, che sono cresciuti e sebbene, abbiano avuto periodi di vita in salita, hanno imparato anche da adulti, e anche sul lavoro, a governare con piccoli preziosi strumenti, gli audiolibri, le mappe concettuali, le complessità dei sintomi. Il merito di un’attenzione che cura, e di una dedizione quella di Pupetta, all’educazione dei piccoli e all’insegnamento degli allievi, ha permesso ad una famiglia e, in primis ad una bambina, come tante altre, di sfruttare una chance di crescita, che non fosse quella di venire colpevolizzata per scarso impegno e volontà, di continuare a vivere in classe come a casa, momenti di demotivazione e frustrazione, fino all’abbandono scolastico e ai graffi profondi nei rapporti genitori figli.
Ginevra, brillante e luminosa come la titanide Febe dalla corona d’oro, fondatrice dell’Oracolo di Delfi, secondo il mito, fende il buio della non conoscenza e della non consapevolezza e come scrive Esiodo nella Teogonia, con la sua luce germina affinché un nuovo futuro possa prendere forma. E Ginevra ha costruito il suo futuro ed oggi è pronta a sostenere se stessa e la piccola Gioia nella crescita.
Ella è diventata la donna, che può a sua figlia dare risposte empatiche e amorevoli, a partire da quelle ricevute da bambina, che hanno segnato il cambio di corso, quando ascolto e competenza si sono incontrate in una maestra. Ginevra ormai adulta, perdona la non conoscenza di ieri in chi, come genitori e insegnanti, a suo tempo, non ha capito, si è spaventato ed ha chiuso, orecchie e mente a ciò che appariva diverso, ma oggi come faro, come un vero e proprio oracolo, è fonte di ispirazione per se stessa e la sua bambina, costruendo con una luce riconquistata, condizioni più favorevoli attraverso le quali trasformare, con le proprie azioni, nuove menti e nuove coscienze. Ginevra con la forza titanica di Febe, incede fiera portando in alto il significato di quell’ascolto ed accoglienza attivi, che diventano per dono dell’attenzione salvifica nei confronti di ogni essere umano e consacrazione così di un mito sempiterno.

io sono Febe
Storia di Vincenzo
ROMANO BATTAGLIA
La notte non è mai così nera come prima dell’alba, ma poi l’alba sorge sempre a cancellare il buio della notte.
Storia
di
Vincenzo

Il cielo è ancora coperto. Il sole pigro non ha ancora dato cenno di svegliarsi, in questa giornata di metà estate.
I barchini sono già pronti per uscire, ma la Marina Grande è ancora vuota.
Si aggirano solo i vecchi lupi di mare e qualche badante che si gode il suo caffè di buon mattino prima che un altro giorni inizi.
Vincenzo li conosce bene quei barchini. Da piccolo, ancora assonnato, il padre lo portava all’alba lì, alla Marina Grande, a pescare. A lui toccava infilare i vermetti all’amo come esca, e lo faceva sbuffando, insonnolito e affamato. Ora era lì di nuovo dopo quarant’anni. Ma tutto gli sembrava diverso.
Ogni singolo istante. In quel lieve vento di scirocco, delle prime ore del giorno c’era il senso di un mattino che ha davvero l’ora in bocca. La giornata sarebbe stata lunga e Vincenzo lo sapeva bene.
Vincenzo lo sa.
Ma è felice. Felice di essere tornato nei suoi luoghi, nella sua terra, tra la sua gente.
Un ritorno alle origini che per lui risuona come un segnale di nuova vita.
Sa che è la sua possibilità, la sua volta buona. E ha voluto riprendere proprio da lì, da quella Marina Grande, dalla sua Isola, famosa in tutto il mondo per i Faraglioni, che d’estate si riempie di quel caos frenetico che sgorga dal porto, nave dopo nave, attracco dopo attracco.
Grida a squarciagola Vincenzo con quel tipico fare pittoresco dei marinai partenopei che gesticolando, racimolano attorno a sé i turisti.
La meta è sempre la stessa. Quella Grotta Azzurra dal blu intenso, quasi accecante, in cui, da piccolo con gli amici di infanzia, amava nascondersi facendo a gara a chi urlava più forte. E in men che non si dica inizia il rituale di sempre, appreso dal padre, e che il padre aveva appreso dal nonno a sua volta.
Quella lenta marcia verso la grotta, di quei barchini che uno dopo l’altro si incamminano con i propri Caronte, ondeggiando con il ritmato e languido sound dei remi che, l’uno dopo l’altro, accarezzano le onde.
Sembra quasi che non le tocchino affatto, e a un tratto l’ingresso: un movimento veloce e deciso per entrare nell’anfratto, quasi violandolo.
E poi in un attimo tutti dentro, quattro, cinque persone alla volta non di più, e l’incedere si fa di nuovo lento, affannoso, affaticato, quasi a voler recuperare fiato.
Gli occhi stranieri disorientati da tanta bellezza e storditi dalle voci lamentose dei marinai che accennano le antiche canzoni dei pescatori.
La magia dura poco il tempo di chiedersi se tutto questo sia reale e poi di nuovo finalmente fuori, il sole in faccia e lo scroscio delle onde. Finalmente si respira di nuovo.
Vincenzo era tornato lì, alla Marina Grande, alla Grotta Azzurra, quell’estate, il periodo estivo era il migliore per mettere insieme qualche soldo in più.
E così era tornato alla sua gente.
Ormai era un anno, poco più, che ne era fuori, ma il tunnel lui lo conosceva bene.
Grigio e cupo. Plumbeo come il cielo d’inverno. Profondo come le acque a largo della sua isola. Ardito come le altezze da cui aveva osservato la sua Capri, dal Monte Solaro.
Arido come i tratti più impervi della sua amata Anacapri.
Quel tunnel era durato tanto; quasi vent’anni, tra cadute e ricadute. Ma non erano come quelle che ricordava di aver fatto in piazzetta giocando a pallone da bambino.
Ormai ne era uscito, ma in quei vent’anni, buio e luce, adrenalina e apatia, sorrisi e lacrime si erano alternati vorticosamente a ritmi regolari.
Un giorno le cose cambiarono.
La porta del carcere si era chiusa dietro di sé, dopo l’ennesimo errore, e ad aspettarlo c’era lui Claudio, che aveva conosciuto nel centro di recupero. La sua reazione, timore misto a sorpresa, si disperse in un secondo appena Claudio avanzò e gli tese un saluto a mo’ di rapper. Così si erano sempre salutati.
È quel gesto conosciuto, quasi intimo, lo rassicurò.
Claudio aveva bisogno di una mano per il nuovo servizio di trasporto pasti all’ospedale che di lì a poco sarebbe partito, e aveva pensato a lui. Proprio a lui.
Vincenzo, seppur timoroso non voleva deluderlo e sapeva che Claudio sarebbe stato il suo angelo. Ruvido a tratti, di poche parole, ma concreto.
Di lì Vincenzo colse il senso di quell’incontro. Era la sua opportunità. La sua volta buona. Di lì iniziò l’attività di trasporto pasti all’ospedale. Era uno di quei pochi che ce la fanno. Tanti ne aveva lasciati dietro di sé.
Dietro di sé nei boschetti, invasi di siringhe. Dietro di sé nei vicoli di notte. Dietro di sé tra le sbarre, dopo l’ennesimo errore. Dietro di sé nel centro che aveva più volte frequentato, e più volte lasciato.
Ma ora era lui a stare avanti. Il primo a presentarsi a lavoro.
Il primo a presentarsi al centro. Il primo tra i suoi amati barchini. Il primo ad entrare e il primo ad uscire da quella grotta cristallina, proprio a voler rivivere ripetutamente per un attimo quell’oppressione del tunnel vissuto per anni, che con la sua sola forza era stato capace di lasciarsi alle spalle.
Era bastata un’opportunità. Il sentire di poter ancora sperare in una nuova vita. L’illusione di poter superare la delusione. La certezza di dover contrastare l’irrequietezza quella dell’animo, quella che confonde, quella che scava, come l’onda nella roccia.
Anche Vincenzo, conosceva l’impeto di quell’onda fluida, ma al contrario delle fanciulle greche che si immergevano nell’acque di Oceano, prima delle nozze per rubare la sua potenza generatrice, lui nei fluidi aveva trovato solo vuoto e perdita.
L’onda, che sin dalla tenera età gli era stata benevola, Vincenzo l’aveva conosciuta anche nel suo lato più oscuro e periglioso, e per due decenni lo aveva dominato, insinuandosi dapprima emotivamente e psicologicamente ed infine anche fisicamente, in cambio di dosi e pezzi di vita. Con il suo gruppo al centro aveva allenato disciplina e fisico a reggere ai colpi dell’onda distruttrice e non era stato facile. C’erano ore in cui frasi anche non dirette a lui o osservazioni banali gli scatenavano reazioni di rabbia incontrollata e dannose.
Con le ore trascorse insieme all’equipe multidisciplinare, i protocolli, il percorso dei dodici passi, gli esercizi fisici e cognitivi, gli individui che incontrava tornarono ad essere persone, a cui non doveva rubare i soldi per racimolare una dose di morte, a cui non doveva mentire sul perché le sue pupille fossero dilatate e parlasse vorticosamente, non doveva giustificare tutti i comportamenti e i suoi sbalzi di umore. E con il tempo e l’impegno il futuro prese la forma dell’acqua vivificatrice. Come Oceano, Vincenzo, fluido come le acque, sembrava possedere un’inesauribile potenza generatrice. Come Oceano però non era un dio fluviale comune, perché il suo non era un fiume comune; quando tutto aveva avuto già origine da lui, esso continuò a scorrere agli estremi margini della terra, rifluendo in se stesso, in un circolo ininterrotto. I fiumi, i torrenti e le sorgenti, anzi il mare stesso, continuavano a scaturire dal suo corso vasto e potente. E vasto e potente, poteva essere ancora il suo futuro, una volta che un’opportunità lui l’aveva avuta. Vincenzo lo sapeva bene. Vincenzo lo sa. Lui nella sua isola ne ha visti di mari agitati e tempestosi, ma è testimone anche che la quiete torna sempre e che il vero marinaio si vede nelle acque agitate. Ma ora è lui ad avere il vento in poppa. Naviga sereno in un mare calmo senza vento, pronto a salpare verso la sua nuova vita, sapendo che l’ancora lo terrà ben saldo, ora che ha saputo smettere di dire ancora.

io sono Oceano
Storia di Sara
KARIN BOYE
Certo che fa male, quando i boccioli si rompono, male a ciò che cresce, male a ciò che racchiude.
Storia
di
Sara

Le note di Brahms aleggiavano nell’aria ancora calda di fine estate.
Le sue danze ungheresi, tra improvvise accelerazioni, alternate a motivi, a tratti spavaldi a tratti malinconici, spingevano su accentuazione ritmiche, dal lentissimo al velocissimo.
Era una delle tante sere all’Aperia della Reggia, e in quello scenario fiabesco quasi surreale, Sara nel suo tailleur blu avion, prestava servizio come hostess. Erano ormai un po’ di anni che era solita trovarsi un lavoro estivo per pagarsi le meritate vacanze.
Non ne aveva bisogno, ma le era sempre pesato chiedere. Chiedere soldi, come chiedere aiuto, conforto, perdono, o semplicemente un consiglio, le era pesato sempre e tanto. E ormai pareva che a pesare, nella sua vita, fosse solo chiedere, ora che, a pesare solo quarantadue chili era lei, leggera come una libellula, fragile come un guscio d’uovo fresco.
Le sue amiche, più che amiche, colleghe di divisa, come soleva appellarle, terminato l’accompagnamento degli ospiti ai propri posti, si defilavano intente a scherzare, chattare, giocare al cellulare. Ma lei no, restava al suo posto vigile e assorta.
Era come se il vorticoso ondulare delle braccia del direttore d’orchestra la rapisse, trasportandola in mondi fantastici che la stessa bacchetta pareva disegnare nell’area immobile. Rapita e trasportata Sara sapeva perdersi in quei gesti, in quelle melodie sinuose, vibranti, angosciose a volte, docili come carezze sul volto dei bambini, altre.
È a perdersi però era stata lei, quando tre anni prima un’altra notte, l’ennesima, di quelle terribili e infinite, l’aveva portata l’indomani a recarsi al centro, pronta a farsi aiutare,
o almeno credeva. Ormai tre lunghi anni erano trascorsi e Sara era davvero uno scricciolo, ma sembrava l’unica a non accorgersene. Ogni anno la divisa di hostess le veniva ordinata di una taglia in meno ma lei voleva di più.
E venne il tempo anche quell’estate di partire.
Un simpatico trullo con due amiche del gruppo di ballo, a cui si dedicava sin da piccola, era la destinazione di quella vacanza. Le ragazze avevano scelto una meta più defilata, ma solo per alloggiare. Il trullo, tra gli ulivi, nelle campagne salentine, era a pochi chilometri dalle spiagge più affollate e movimentate.
Questo contrasto piaceva a Sara, come se si adattasse perfettamente al suo sentire. Come quelle danze ungheresi che giorni prima la rapivano e frastornavano.
Aperitivi assordanti, mattine quiete, pomeriggi lenti, notti concitate; un’estate che trascorreva, giorno dopo giorno, come il Bolero di Ravel, lento, lentissimo, e poi sempre più veloce e roboante; stridulo, e poi pieno.
Così come stridulo e poi pieno fu l’ultimo atto, e d’improvviso il buio, e Sara si svegliò, dopo il suo ennesimo ricovero, davanti gli occhi increduli e terrorizzati di mamma e papà.
Ad ogni ricovero, era sempre più arrabbiata, aggressiva, quasi percepisse l’ingiustizia di quel blocco coatto, non comprendendone la necessità.
Ma quella volta qualcosa cambiò. Ma a cambiare non fu lei, e di lì a poco si trovò in stanza con Vanessa. Lei pesava più di ottanta chili, e il solo vederla la nauseava.
Non le rivolse la parola per settimane, fin quando Vanessa intenta a pettinare le sue Barbie, di cui aveva una collezione sterminata, non attirò l’attenzione di Sara.
Fu un balzo indietro nel tempo.
In un attimo si ricordò di quando, da piccola, passava interi pomeriggi insieme a loro, sola in casa, mentre mamma Claudia e papà Sergio erano a lavoro.
Di lì divennero amiche.
Sara imparò a non vedere più i chili di troppo che ingombravano Vanessa, così come riuscì a non veder quelli che le mancavano per considerarsi sana.
Giorno dopo giorno, iniziava a sentirsi schiacciata dal suo peso inesistente, e una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò, con lo stesso lento crescendo della melodia che accompagna questi versi della celebre romanza di Donizetti.
Un solo istante, i palpiti del suo cor’ sentì.
E fu Vanessa a sentirli quei palpiti, e l’abbraccio, il primo tra le due siglò il loro sodalizio, tra i digiuni dell’una e le grandi abbuffate dell’altra.
Entrambe fagocitate dalla malattia del nulla granitico, del vuoto impalpabile, del silenzio assordante, come vittime di un elisir d’amore, che lascia inermi, ciechi, immobili.
Ed è proprio l’amore il nodo centrale che lega con un fil rouge le storie di Sara e Vanessa.
Diverse, opposte, storie di genitori oppressivi l’una, storie di assenza per l’altra, ma forse semplicemente genitori, in una storia sbagliata dal destino nebuloso o solo sfortunato.
Si l’amore. Quello ricevuto, perduto, dato, abortito, sbagliato, abusato che, nella sua forza energica e travolgente a volte straripa, andando oltre i perimetri di un cuore capace di sopportarlo. È alle emozioni che entrambe avevano detto basta, ibernandole nei lunghi digiuni, e nelle compulsive abbuffate, ognuna a suo modo.
Ed è ognuna a suo modo che ne sarebbero venute fuori, che ne sarebbero uscite, ognuna sull’incedere delle proprie melodie, delle proprie rinunce, denunce, dei propri passi, gesti, dei propri sforzi. Uno dei doni più grandi che la Residenza le aveva lasciato, dopo quello di averla accolta, era certamente una maggiore consapevolezza, la prima di non presumere più di essere in salute o sentirsi attraente, guardando i numeri su una bilancia, l’ultima, che chiedere aiuto le aveva salvato la vita.
Chiedere non spaventava più; era solo il verbo infinito che le ricordava quanto fosse importante esprimere il desiderio di avere o di ottenere qualche cosa, quanto fosse importante la volontà di riabbracciare la vita.
Ognuno aveva le sue ossessioni, fobie, paure e timori, alla residenza, e questo la faceva sentire meno sola. Il tempo al centro terapeutico passava, passavano le giornate e si facevano faticose, affannandola, spesso lasciandola per giorni apatica. Immobile a letto. Si muovevano nell’anima sentimenti contrastanti quando pensava alle conversazioni in gruppo al centro con i compagni e le compagne di ventura, anche di uomini ormai ce ne erano proprio tanti, e questo la lasciava perplessa, esterrefatta. Sara rimaneva conquistata da quanta umanità si potesse sentire nel respiro sospeso di chi, seduto in cerchio come gli indiani, iniziava le prime volte a raccontare frammenti di sé a perfetti sconosciuti, che sarebbero diventati per i mesi a venire, imperfetti amici di corridoio, nel respiro paziente di chi ormai veterano cominciava a parlare di sé, per dare uno sprono a quanti si trovavano seduti ignari e incapaci di dare voce ai loro vissuti e alle emozioni; il respiro concitato e voluttuoso di chi non agognava altro che vomitare emozioni e pensieri all’unico gruppo da cui non si sarebbe sentito giudicato. C’era Acidella, che rivelava di mangiare poco per poter influenzare gli altri, c’era Vanessa soprannominata nei corridoi Bubu per quell’andatura flemmatica e quei suoi foulard dai colori eccentrici, che mangiava in eccesso per cercare gratificazione e fronteggiare i suoi momenti difficili; c’era Pulce che raccontava di un’estenuante attività fisica, che la aiutava a perdere peso, e soprattutto le smorzava gli stati emotivi più intensi che sembravano inghiottirla. E c’era chi come lei mangiava meno per mantenere la sensazione di controllo. Le riunioni non erano una passeggiata; era sfibrante mettersi in gioco, ma il terapeuta, attraverso quel vigile ascolto delle sue preoccupazioni la sosteneva sempre molto e non la faceva sentire sola. Altri giorni, andava meglio, ma altri no. A volte Sara si sentiva ancora come all’inizio: rancorosa, irritabile, nervosa e indisponente; con quell’accidia che ti uccide, che anche alzarsi dal letto, diventa faticoso, un ostacolo insormontabile. Il freddo costante, la paura, l’apatia, il senso di colpa, il timore, il terrore. Le lacrime che uscivano pesanti, lente, ad una ad una come da un contagocce, staccandosi poi come ceralacca. Lente e disumane, lacrime che si annidavano come api, si moltiplicavano come pulci, si allargavano come zecche, cementandosi come stucco sui muri. Altri giorni andava meglio. Altri giorni va meglio. Irremovibile, come Temi, personificazione dell’ordine, della giustizia e del diritto, Sara sembra rappresentare appieno la titanide, con la sua ossessione per la legge, la sua fobia per l’ordine. Temi a cui nell’antichità si usava rivolgersi quando si doveva prestare un giuramento, spinge Sara a invocarla ogni mattina, quasi a prendere da lei la forza titanica per fare quel primo infinitesimale gesto: svegliarsi. Sara oggi si alza la mattina. Che ci sia la pioggia o il sole, che sia nuvoloso o ventilato, grandine o neve, Sara si alza. Che sia una bella giornata o una di quelle da dimenticare, finalmente Sara si alza. È sveglia, apre gli occhi e c’è. È viva, viva per davvero.

io sono Temi
Storia di Cristian
MARIANGELA GUALTIERI
Sento il tuo disordine e lo comparo al mio.C’è somiglianza. C’è lo stesso slabbro di ferite identiche. C’è tutta la voglia di un passo largo in una terra sgombra che non troviamo.
Storia
di
Cristian

Dondola dondola. Ma il suo sguardo sembra quasi immobile. Nessuno riesce a capire cosa pensi quando è così, seduto sull’altalena con le gambe a penzoloni, gli occhi semi chiusi
e le labbra arricciate.
Da qui sembra quasi riuscire a contare ad una ad una le foglie del prato inverdito dalla bella stagione, dove di qui e lì sbucano i fiorellini di campo, tutti diversi tra loro, unici, che, sfidando la natura, sembrano ribadire il loro carattere speciale.
La matematica era stata sempre una sua grande passione, di quelle che diventano ossessione. Le parentesi quadre, tonde e graffe uscivano dalla biro come schizzi d’autore, i numeri si accavallavano uno dopo l’altro; e così fu alcuni anni dopo con le brevi e semibrevi, e poi con le crome e le chiavi di violino prima, di basso dopo.
Musica e matematica, matematica e musica: un universo fatto di melodie spesso incomprensibili capaci di spaziare dalle note apparentemente stonate del jazz a quei sound metropolitani un po’ urbani di chi, ormai bravissimo a replicare i vasti repertori di musica classica, sperimenta e si sperimenta con altri suoni, alla ricerca di quelli in accordo con la propria anima. Cristian era capace di stare lì ore ed ore a quel piano, ma a volte saltellava come una cavalletta impazzita dal piano al violino, e poi alla batteria, l’ultima new entries in quegli ottanta metri quadri, che facevano da cornice alle nostre vite da venti anni. Il ricordo torna indietro di circa dieci anni, quando per il suo decimo compleanno Cristian trovò in casa il suo primo pianoforte. Avevamo fatto fuori la vetrinetta di cristallo per farvi spazio, e Cristian quando lo vide sembrò apprezzare di non averla tra i piedi, grazie a quello che divenne ben presto il compagno di lunghi pomeriggi.
Con la stessa maniacale precisione con cui teneva in ordine i suoi libri di musica, gli spartiti e la sua collezione di lattine cangianti che auguravano la buonanotte in tutte le lingue, così Cristian si dedicava ad apparecchiare la tavola alla sera. Era stato il suo compito da sempre, e vi si concedeva con dedizione, esibendo anche un po’ di creatività che esprimeva scegliendo come centrotavola, un oggetto della casa, sempre diverso. Una volta ricordo che mise il ferro da stiro inaugurando la cena esclamando: che i vostri pensieri si stendano come lenzuola appena stirate. Buon appetito!
Già; i pensieri, affascinanti e intollerabili, fonte di mirabili evoluzioni mentali e allo stesso tempo pesanti croci che ti lasciano a volte esterrefatto, a volte frastornato, che trasformano la tollerabilità umana in agonia. La facoltà del pensare, quella che i più danno per scontata, sempre a loro disposizione e inscalfibile, quell’attività psichica mediante la quale uomini e donne acquistano coscienza di loro stessi e della realtà
in cui sono calati, proprio quella facoltà per noi si sgretolò in una tarda primavera di tre anni prima, come i pupazzetti di sabbia modellabile con cui prendevano forma i suoi originali compagni di avventura. Ricordo che lo spiavo quando era piccolo, incuriosito da quale sarebbero stati i suoi scenari avventurosi e poi aspettavo paziente che mi chiamasse al termine, orgoglioso di mostrarmi quanto aveva creato.
Un giorno i pensieri di Cristian si fecero insoliti e confusi, disorganizzati e sospettosi, e presto a loro si affiancarono innaturali e, per noi sempre meno comprensibili, desideri di stare da solo. Le settimane in solitaria iniziavano a sommarsi una dopo l’altra e noi ci sentivamo frustrati, soli e impreparati, dal momento che con i nostri mezzi, armi spuntate contro un nemico ricco di tranelli, non riuscivamo a tradurre quello che si agitava nella sua mente. Pian piano imparammo con gli anni, con un aiuto assiduo e un’indomita disciplina a saper leggere, sempre troppo poco, la gestualità ridotta, l’espressività del suo viso cambiare, i passaggi frenetici e poi immobili di un eloquio foriero di genio e felicità, quando applicato agli amori della sua vita, la matematica e la musica; dubbiosi e tormentati, invece, quando le energie mentali si incanalavano in deliri paurosi e infiniti. Ricordo i medici che parlavano di una recovery il più ampia possibile, di buone possibilità di intervento, grazie al fatto di avere individuato i suoi curiosi atteggiamenti non in tarda età, e ricordo me stesso pensare che recovery, mi sembrava una brutta parola, dato che in italiano echeggiava a ricovero. Il mistero mi fu svelato dalla psicologa dell’equipe multidisciplinare, che prese Cristian in carico e con lui le paure i dubbi e lo sconcerto di noi altri, e che lesse nella mia incapacità di far domande, il terrore di conoscere il significato delle risposte. Recovery, invece, acquistava dopo quel suo ascolto di silenzi e paure, la frontiera da conquistare a lungo termine, il recupero del funzionamento individuale e sociale di Cristian, il ritorno alla normalità. La musicoterapia iniziò a trovare in lui uno spazio da ricaricare e riseminare, al fianco dei trattamenti farmacologici, dando un senso all’incedere del tempo e delle esperienze; e Cristian così divenne man mano un mentore per quanti frequentavano il centro diurno.
Se un tempo recovery mi portava alla mente un presente e un futuro angosciante, poi, grazie all’aiuto di Alessandra che aveva avuto sempre un tempo per me, papà smarrito, a volte sfiduciato, ma un padre pur sempre fermo a combattere quella battaglia insieme a suo figlio, quella parola si tradusse in discovery, una vera e propria scoperta del nuovo mondo di Cristian, ma soprattutto degli infiniti itinerari che mi sarebbe stato possibile percorrere con lui, dentro di lui, dentro di me.
Le nostre giornate restano piene di impegni tra lavoro e casa, e i pomeriggi al campo di calcio con Francesco, che pur di sfuggire alle versioni di latino e greco del ginnasio era pronto a fare anche doppi allenamenti. Per la sera si ripete il preciso rituale, che Cristian continua ad interpretare al meglio: un oggetto al centro, i nostri occhi smarriti e la sua chiosa che non tarda ad arrivare. Ormai abituati, sappiamo che un solo debole cenno di un sorriso può causare una crisi aggressiva o una valanga di pensieri sconnessi, che un tempo avrebbero ibernato ogni singolo movimento del nostro volto. Una ritualità quella dell’oggetto centro-tavola che come un totem ci auguriamo ci salvi, prima o poi; ci salvi tutti dal cambiamento e dall’incertezza. Ormai abituati, sappiamo che un grazie, un semplice grazie, a inizio cena, può bastare a Cristian, che così prevede vadano le cose, sera dopo sera.
Come Crono, nipote di Caos, Cristian sembrava aver rintracciato una sorta di memoria genetica del disordine al quale si oppone interpretando la versione greca del titano del tempo che lo conduce verso le sue passioni per la musica e la matematica; e dall’altro, quella romana del titano del tempo, ovvero Saturno, pianeta sul quale sembra migrare quando si allontana con i suoi pensieri. A differenza di Crono, però, che scacciò i fratelli Ciclopi, confinandoli nel Tartaro, Cristian, giorno per giorno, sa bene quante insidie, spesso dolorose, gli provochino i suoi fratelli, i suoi fraterni pensieri; ma Cristian con i suoi pensieri a volte sconnessi, cerca di muoversi un passo dietro loro, quasi a volerli tenere a bada, convinto che come Crono, la sua battaglia quotidiana lo possa far diventare Re dell’Isola dei Beati, dove sono destinati gli eroi che hanno lottato con sagacia, estremo vigore, indefessa attitudine; sull’isola, finalmente lì, eroi felici e liberi dagli affanni.

io sono Crono
Storia di Lara
CHARLES BUKOWSKI
Se è possibile essere felici, lo sarò. Non farò il difficile e anche se non sarà la felicità perfetta non farò lo schizzinoso. Mi prenderò tutta la felicità che posso prendere.
Storia
di
Lara

La mano permette all’intelligenza non solo di manifestarsi,
ma di entrare in rapporti speciali con l’ambiente.
Questo sosteneva la maestra delle maestre, quella Maria
a cui si riconducono tutti i migliori metodi di apprendimento per bambini.
E Lara, quattro anni, quasi cinque, il mese prossimo, lo sa bene. È da quegli stentati dieci centimetri che inizia ogni mattina.
Una mano per prendere il tazzone di latte, ingurgitato di fretta con gli occhi ancora assonnati.
Una mano per rifarsi il letto, l’altra per lavarsi i denti con quel gusto fragola che le piace tanto misto al toast con doppio formaggio, perché a lei piace la colazione salata.
Una mano per scegliere con cura cosa indossare, provando abbinamenti a volte inediti, ispirati alle sue eroine più ribelli.
Adora il giallo. Quello sole, forte ed energico come lei.
Quel giallo che in una molletta, un nastrino, un accessorio, non manca mai.
Inizia ogni mattina, Lara, con i suoi dieci centimetri di manine. Una mano per chiudere il cestino in cui la sera prima ha riposto con cura la sua merendina per l’indomani.
Una mano ancora per salutare la sua bambola Camilla che l’avrebbe attesa come ogni giorno pazientemente.
Una mano, anzi due, che sbattono a mo’ di piatti per sollecitare il Papi ad accompagnarla all’asilo in tempo, facendo seguire con la sua voce vivace, quelle tre parole, quasi un jingle mattutino, come il Bianconiglio in Alice nel paese delle meraviglie: È TARDI. È TARDI. È TARDI!
Ma Lara sa che quella è una favola, e che è diversa da quella realtà quotidiana che per il suo mezzo metro è già scandita da ritmi, gesti, parole.
Tante parole che cattura come prede da collezionare.
Lara entra correndo, salutando il suo papà, ogni mattina.
Lara inizia la sua giornata, ha tante cose da fare oggi. Oggi, ha tanti impegni.
Oggi costruirà la sua amata stazione dei pompieri.
Metodica, precisa e volenterosa sistema ad uno ad uno quei magici pezzettini colorati, dividendosi per tipologia e per colore e pianificando pian piano il suo progetto, come gli ha insegnato il suo eroe, Roberto, quel fratello maggiore a volte distratto, che lei adora.
Non ne ha ancora impilato neanche uno, ma è intenta a spiegare a Carlo il suo amichetto di giochi, cosa farà. Con quelle dita di pochi centimetri delinea spazi, gesticola come un prestigiatore, agitandosi con entusiasmo per ciò che avverrà.
Carlo la segue nei suoi ragionamenti, ma poi incredulo e impaziente la sollecita ad iniziare, offrendogli il suo supporto. Cominciano silenziosi, fin quando Matilde arriva chiedendo di unirsi, e scatta uno dei tanti litigi, quelli chiassosi dei bambini.
Ma Lara inizia così il suo gioco preferito.
In un attimo il telo dei giochi diventa la sua toga, il porta pastelli, martello, e lei, con aria e postura autorevole, drizzando le spalle e congiungendo le mani, apre le danze.
Invita Carlo e Matilde a non accavallarsi.
Li rassicura che li ascolterà entrambi. Spiega le regole. Poche, ma chiare.
Volge lo sguardo a Carlo il più refrattario invitandolo a restituire la sua versione dei fatti.
Matilde dopo poco prova a interrompere, ma Lara decisa interviene e solo con uno sguardo ripristina le regole.
Vanno avanti per un po’, sotto lo sguardo vigile, incuriosito e a tratti divertito delle maestre che con un occhio alla classe da un lato, non distolgono, però, lo sguardo dai tre, rapite dalla capacità di Lara di tenere tutti a bada, riuscendo alla fine ad arrivare alla stretta di mano tra i due litiganti. Lara ha solo quattro anni e mezzo, ma sa già che cosa farà da grande: o il pompiere, o il giudice, dice, come la sua mamma che, sera dopo sera, viene intervistata da Lara che, sin da piccolissima, ha preferito alle favole della buonanotte i racconti giornalieri della madre, quasi a volersi spiegare le mancanze, le assenze, le partenze, con quel precoce desiderio di dare un senso alle cose.
E con le sue manine di appena dieci centimetri, un senso lei lo dà; lo dà sempre quando lascia scivolare tra le dita i petali rossi e le perle profumate, nel fare compagnia in bagno alla mamma prima di cena, chinata a bordo vasca.
È con le sue mani che aiuta Roberto ad apparecchiare, riprendendolo quando scambia il posto a forchetta e coltello.
È con le sue mani congiunte che ringrazia prima della cena intonando le note della preghiera.
È con le sue mani che tira il grembiule alla madre invitandola a sbrigarsi, che il cartone inizierà tra poco.
È con le sue mani che stringe Camilla che, paziente, giorno dopo giorno, l’aspetta.
Oggi è un nuovo giorno per Lara.
Come Teti, figlia di Urano e di Gea, Lara sembra incarnare la dea babilonese delle acque salate, così come descritta nell’antichità. Sembra avere quel dono della metamorfosi, che così come per la titanide, contribuiva ad aumentarne il fascino.
È affascinante e fascinoso, infatti, il suo cambiar pelle ogni giorno, sfidare i propri limiti, mettersi alla prova nelle tante piccole vicende del quotidiano; un quotidiano operoso e frastagliato, fatto di piccoli, infinitesimali gesti che man mano cambiano la vita di Lara, la cambiano e la fanno crescere. È ancora una volta lì Camilla, pronta a farsi quasi soffocare da quegli stritolatissimi abbracci, che si moltiplicano ad ogni clic di luce.
Ad una ad una vanno spegnendosi, e il buio avanza. Ma Lara resiste, sa che prima o poi ce la farà a sopportarlo. Per ora sono le stelle a guidarla, quelle che illuminano la parete della sua cameretta. Quelle riposte ad una ad una con sua madre in una delle tante domeniche assieme, con la pioggia roboante che fuori accelera, mentre in casa tutto sembra accarezzato da quella lentezza magica dello stare bene insieme.
La domenica è un giorno buono per Lara. Sa che si potrà concedere qualche capriccio, qualche vizio, un gelato, un cartone in più, prima che riinizi il tran tran della settimana. Ha ancora qualche ora Lara, prima di riprendere il suo ruolo, i suoi compiti e dimostrare che lei con le sue manine di soli dieci centimetri, giorno dopo giorno, ce la sta facendo
a diventare grande.
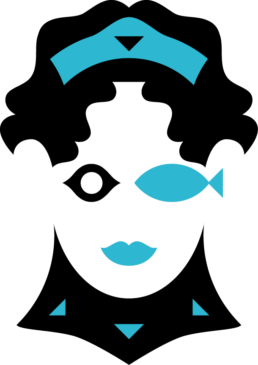
io sono Teti
Storia di Remo
PINO DANIELE
Passa ‘o tiempo e che fa, tutto cresce e se ne va, passa ‘o tiempo e nun vuò bene cchiù. Voglio ‘o sole pe’ m’asciuttà voglio n’ora pe’ m’arricurdà.
Storia
di
Remo
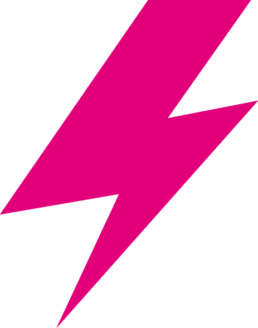
Un’aria torrida entrava dalla finestra, interrotta da improvvise e inaspettate folate di quel venticello debole dello scirocco. Le forbici cromate, il pettine a punta, le lamette ancora intatte e quel pennellone di cinghiale immancabilmente eretto sul bordo del lavandino, tutti in fila per dare inizio al consueto rituale mattutino.
Con la precisione e la maestria di un barbiere di altri tempi, Remo impugna le forbici pronte ad affilare i suoi folti baffi carbone che, ormai da cinquant’anni, incorniciano quel fascinoso sorriso, ormai velato dopo altrettanti anni, dal fumo evanescente di quei toscani immancabilmente nascosti dietro la pochette.
Ormai li aveva un po’ trascurati, i suoi amati toscani, dopo l’ultimo controllo medico dal cardiologo davanti al quale con un sorriso esordì: dottò li vuoi allungare i miei giorni; ma io ho l’obbligo di allargarli.
Allargare le giornate. Questo era stato sempre il mantra di Remo. Settantasei anni suonati e un’irrinunciabile voglia di vivere. Amante di De Crescenzo, da buon partenopeo, aveva fatto suoi gli insegnamenti del grande maestro. Epicureo o stoico? Dichiaratamente, irrimediabilmente, convintamente epicureo. La vita lui la voleva decisamente allargare. Diluirla, perché i ricordi dei lunghi baci sul Ponte Vecchio quando da giovanissimo, militare a Firenze, si trastullava tra una donna e l’altra, in attesa di far ritorno per il congedo dalla sua Elena, non sbiadissero. Fluidificarla, perché il pensiero volato via alle spensierate estati e alle notti brave con gli amici di gioventù non sembrassero un ricordo lontano. Remo aveva vissuto così tutta una vita, mosso sempre da un acuto senso della bellezza. Non si trattava solo di vano narcisismo, ma di un più profondo senso del bello che sin da piccolo aveva maturato dentro di sé, quasi a contrastare, creandosi un mondo incantato e sognante, i primi anni del post guerra, duri ma felici, in cui non si aveva niente, ma quel niente che bastava a vivere e a sentirsi più fortunati, di tanti, che i propri padri non li avevano visti tornare. I suoi occhi non potevano sopportare le brutture, le storture, le ingiustizie. Da buon sagittario, vigoroso, profetico, dinamico, Remo, aveva un mondo interiore ricco e stimolante, costruito sulle note delle malinconiche canzoni d’oltralpe, sulle immagini d’oltre oceano, il tutto misto agli odori, i profumi, i gusti di quella napoletanità che prima di un luogo di origine è un modo di essere.
Quel modo di essere che lo portava a raccontare infinite volte la stessa storia, come nell’episodio del cavalluccio in Così parlò Bellavista; quel modo di essere che lo portava ad esultare, senza mai trascendere, composto ed elegante com’era, ad ogni goal del Napoli; quella calcistica, fu la sua unica fede. Apparentemente eretico, forse agnostico, in realtà aveva sempre creduto nell’al di là, ma, da buon illuminista non lo diede mai a vedere, e la sua passione per le donne d’adulto, per i giocattoli, tutti quelli che non poté mai avere, da piccolo, rafforzarono il suo convincimento per l’amore verso le cose terrene. Sosteneva che amare e innamorarsi, giorno dopo giorno, della terrenità era l’unico modo per avvicinarsi al divino. Appassionato sin da giovane di meccanica aveva fatto i suoi studi al tecnico commerciale; e di lì a poco fu pronto per partire con la sua vuota valigia di cartone, come spesso succedeva al tempo, per il Nord, come si soleva dire. Scaltro, quel che basta, trovò subito lavoro in una multinazionale tedesca che commercializzava utensili, e di lì ben presto, l’odore d’officina delle più prestigiose aziende metalmeccaniche divenne il suo marchio di fabbrica.
L’odore persistente delle lavorazioni meccaniche, miste al fumo del toscano classico, annunciavano profeticamente il suo rientro a casa, dove, ad aspettarlo c’era lei, Elena la sua compagna di sempre. Con lei, le sue due splendide figlie, che per testimoniare la sua modernità non volle chiamare come la madre, rinunciando pionieristicamente a quella famosa e consueta tradizione della cosiddetta supponta. Remo viveva della sua vita vissuta. Le figlie lo andavano a trovare quasi ogni settimana, ma senza le nipoti quasi a volersi ritagliare un momento speciale per sentirsi ancora bambine. Amava la musica tradizionale napoletana, e continuava ad avere sempre un aspetto curato, Remo. Un dandy inglese per certi versi. Fissato con le cravatte dai colori sgargianti, a cui, negli ultimi tempi aveva preferito fantasie esotiche. Una volta al mese era solito uscire a cena fuori, a volte solo, a volte convinceva qualche amico o amica della casa di riposo, dove ormai da anni risiedeva.
Oggi Remo, è ancora lì. Adora fare lunghe e lente passeggiate nel bosco della casa di riposo; un giardino dove ha trovato un angolo per curare il suo amato basilico, irrinunciabile, tocco su quello spaghettone allo scarpariello che spesso si concede di preparare di persona per tutti. Come Ceo, titano della saggezza, Remo, conserva gelosamente ogni singolo ricordo di quei settantanove anni, più di cinquanta vissuti accanto alla sua Elena. Non fu l’unica forse con cui si accostò, pur rimanendo l’unica donna della sua vita, a cui dedicò, giorno dopo giorno, quelle frasi celebri prese a prestito dalle commedie di Eduardo, con le quali sapeva di riuscire a rubare un sorriso forzatamente trattenuto di Elena, che pur di non dargli soddisfazione, lo apostrofava con improbabili epiteti, senza mai scomporsi. Sei la reginetta della casa, le diceva, facendola sbottare a prima mattina, intenta lei, a dare inizio a tutti quei gesti quotidiani che la vedevano sempre su e giù per la casa, operosa e mai affannata. Remo, intanto, tra le faccende domestiche della sua Elena, si rinchiudeva ne suo mondo fatto di musiche, ricordi, studi; amava la fisica, la matematica, in generale tutte le scienze, ma era irrimediabilmente conquistato dalla letteratura, e dalla poesia; poesie che conosceva a memoria, retaggio della scuola dai libri neri, le penne rosse e i grembiuli con i fiocchi, in cui era cresciuto, spesso inginocchiato dietro la lavagna sui ceci, come si soleva un tempo. La sua saggezza era tutta lì, nei versi dell’Infinito, quel e il naufragar mi è dolce in questo mare, a cui sembra essersi ispirato in ogni attimo della sua vita.
Nelle terzine di dantesca memoria, nei sonetti e nelle formule di fisica, nelle note di Chopin, nei dialoghi incalzanti di compare Turiddu e compare Alfio in Cavalleria rusticana. La sua saggezza era tutta lì, nell’instancabile curiosità con cui silente e spesso taciturno aveva guardato sempre il mondo senza giudicarlo, con quel distacco tipico di chi osserva, spesso smarrito, davanti alle storture, ed estasiato di fronte alle bellezze. Remo ora era lì. Dopo Elena aveva preferito un luogo nuovo dove vivere, cercando di illudersi e illudendosi di trovare un posto in cui tutto non gliela ricordasse ogni minuto.
È un nuovo giorno per Remo; oggi le sue nipotine, lo andranno a trovare; si fa bello, ci tiene a mostrarsi in perfetta forma. Sarà una visita breve, ma intensa; il tempo di un gelato, in giardino, di un saluto che spera sempre possa essere non l’ultimo.