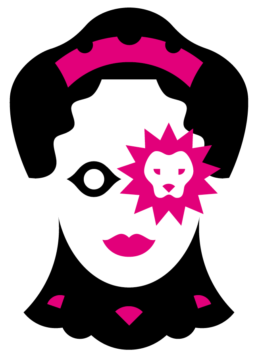Storia di Elsa
GABRIELE D’ANNUNZIO
Cum lenitate asperitas.
Le difficoltà vanno trattate con dolcezza.
Storia
di
Elsa

E scricchiola ancora quel cassetto del comò Luigi XVI.
Il suo suono stridulo nell’aprirsi fa da sottofondo all’odore
di lavanda che proviene dai sacchetti cuciti all’uncinetto.
Si scorgono gli effetti dei tarli, ma sono di meno quelli sul legno, che nella testa.
La mente si estranea per un attimo e le immagini si impilano come soldatini al fronte; al fronte della memoria, pronti
a combattere contro l’eterno nemico di sempre, l’oblio.
È presto, molto presto questa mattina. Ma è un giorno speciale e come tutti i giorni speciali, si ha voglia di iniziarli. Le mani leggere come cartapesta stringono la camicetta di seta, ancora bella piegata e conservata nella sua busta trasparente.
Elsa decide che la indosserà per il suo ottantesimo compleanno. Ci pensa da giorni e si chiede se oggi, smagrita, riuscirà a riempire quel capo, gelosamente conservato negli anni, a cui è tanto affezionata.
La apre e l’adagia sul letto, e uno sguardo titubante l’accompagna. Gli occhi le cadono poi sui riccioli scuri di quei nipoti d’oltreoceano che d’estate e a Natale le riempiono
la casa di gioia; di quella gioia rumorosa, senza motivo né pretese che solo i bambini sanno portare.
Elsa accenna un sorriso e le sue labbra di un rosa cipria, marcate dalle rughe, si distendono subito, quasi borbottando. Le son caduti gli occhiali, e fa fatica a raggiungerli con le mani. Le braccia cadono lievi lungo gli spigolosi angoli della sua sedia amica, compagna di brevi ma tortuosi tragitti. Una voce flebile chiama; è lei che intona: Maria.
La voce tronca, un tono sommesso, ripetono: Maria. E in un attimo, Maria è già li.
Non servono parole, comprende immediatamente e recupera da terra le lenti, e poi si siede ai piedi del letto. Gli occhi di intesa proseguono e, continuando a non dire una parola, Elsa e Maria iniziano il loro consueto gioco di sguardi, espressioni che reciprocamente si incrociano complici.
È un giorno speciale. Oggi che è il suo compleanno Elsa riprova la voglia di iniziarlo presto questo giorno, generalmente scandito da altri ritmi, più affannosi, faticosi, fatti di quell’incedere lento di atti quotidiani che perdendo il loro perché si replicano, annichilendo il senso delle giornate, spesso vuote come i porta pillole alla sera.
È un giorno speciale oggi; ed Elsa lo sa.
Oggi non dovrà fare attenzione alla dieta, non dovrà passare dalla sua sedia amica-nemica, al letto e poi al divano. Oggi non dovrà subire il lento scoccar delle ore al suon di quell’orologio a cucù che sente ritmare il tempo, e che irrompe nel silenzio col suo suono improvviso.
Oggi non dovrà sentire il brontolio di Maria che le annuncia i pasti, le medicine da prendere, e che detta i tempi svizzeri di quelle prassi metodiche che archiviano i giorni uno dopo l’altro.
Oggi non dovrà lasciarsi trasportare dal tempo, ma sperimenterà un’emozione nuova: l’attesa. Quel vibrante intramezzo che ci riserva il cosiddetto frattempo; quell’intanto che arrivano gli ospiti; quell’intanto che si fa l’ora di pranzo; quell’intanto che la tavola sarà apparecchiata. È quella dimensione spazio-temporale dell’attesa che concede sollievo ad Elsa, pronta ad indossare la sua camicia di seta, sentendo che finalmente c’è un tempo che acquista senso, valore, spessore.
Pesa, si, pesa, e lei sente le spalle fragili; ma è felice; li avrà tutti lì, riuniti per lei, dai più grandi ai più piccini. Un’istantanea delle scelte fatte fino ad allora col suo amato Osvaldo che ora l’accompagna da lassù.
E il pensiero le vola a lui, ai sacrifici dei primi anni d’amore, a quel monolocale nei primi anni ‘50 che, man mano, che Osvaldo andava su e giù per l’Italia, e lei a casa ad attendere il suo rientro, si riempiva di nuovi oggetti. Il giradischi regalatole per l’anniversario le fa tornare in mente quella bizzarra abitudine che avevano; al rientro da ogni viaggio Osvaldo metteva su proprio quel disco. Le note sembrano vibrare ancora su di lei come una nuvola: tu sei per me la più bella del mondo, e un amore profondo
mi lega a te. Ad Elsa pare di sentirle ancora quelle parole, che canticchiavano sorridenti, come a voler testimoniare che dopo un altro viaggio, e un altro ancora lei e lui, erano sempre ancora lì, insieme.
I ricordi dei piccoli in cortile a giocare, che richiamava dalla finestra per la merenda; e poi, i primi giorni di scuola, finché loro decisero di spiccare il volo verso le loro vite.
Le lacrime nel salutarli ad ogni partenza e quelle ancor più fragorose nel ritrovarli ad ogni festività. I ricordi sono tanti, indelebili, a tratti sfocati, ma nel cuore vivi e vegeti.
Elsa lo sa. Oggi è un giorno speciale. Oggi, si aspetta. Oggi, si può aspettare; si può sperare. Si può ricordare. Si può vivere. Oggi, si può.
Come Mnemosine, personificazione della memoria, Elsa, è in prima linea nel combattere la sua battaglia contro l’oblio. I ricordi la scaldano, e come la titanide greca, le piace assegnare nomi e vezzeggiativi agli oggetti che la circondano.
E in un attimo, il suo beauty delle medicine diventa scrigno magico, l’ora della siringa, diventa il momento della lente marcia di ingresso di una principessa nel suo regno,
e dei suoi fedeli servitori a seguito, come Maria, instancabile dama di compagnia.
E con il potere della parola, diventa tutto fatato; in fondo la realtà è solo ciò che ci raccontiamo che sia; ed Elsa lo sa; è per questo che, infatti, continua a giocare con personaggi di corte e storie incantate.
Alle porte delle sue ottanta candeline, ci è arrivata così, immaginando mondi possibili e dissetandosi a volte, alla fonte di Mnemosine, per ricordare, e a volte, a quella di Lete, l’oblio, per dimenticare.
Una storia come tante quella di Elsa che riscrive la sua realtà, spingendosi a rinarrarla,
a raccontarsela perché ingoiarla sia meno faticoso.

io sono Mnemosine
Storia di Filippo
JAROSŁAW IWASZKIEWICZ
Il mio mondo è il mio mondo non posso aprirlo davanti a voi. E se anche descrivessi le statue dei dodici mesi celate nel fitto verde, ognuno di voi vedrebbe un verde diverso una statua diversa e non questo verde.
Storia
di
Filippo

Ci siamo! Il giorno è arrivato. È un primo pomeriggio assolato, ma fresco e la mamma e la nonna di Filippo si stanno preparando. Filippo e sua sorella, invece sono pronti da un pezzo, lui siede, sguardo sfuggente, sul divano in attesa di varcare l’uscio di casa, sua sorella Lia, invece, bandana in testa, aspetta con pazienza che il papà tiri fuori la macchina dal garage.
La mamma si rivolge a Filippo con voce tranquilla e gli chiede se è pronto, dopo un po’ gli chiede se vuole un cappellino per il sole, e solo prima di uscire gli porge quello bianco, accompagnandolo con un sorriso. Tutto con i tempi giusti, quelli di Filippo: non troppo veloci, per non sovraccaricarlo, e poterli permettere di fare una cosa alla volta. La gita può avere inizio e i cinque percorrono una mezz’oretta in auto prima di arrivare ad una delle mete preferite da Stefania, la mamma di Filippo.
Sono in anticipo e il parcheggio si trova facilmente.
Filippo si appresta a passeggiare con la sua andatura ciondolante per le stradine di Rocca San Felice, uno dei borghi più belli d’Irpinia, allestito con fascino medievale, nella penultima settimana di agosto.
La sua mamma adora da sempre queste feste rievocative, mix equilibrato di cultura storia e tradizioni. Nei primi due anni di vita di Filippo, lei e il padre vi erano tornati ogni fine agosto, ma poi dopo il terzo anno, i suoni, i colori sfavillanti dei drappi e degli stendardi allestiti in ogni dove, non erano più indicati per la grande sensibilità che Filippo aveva iniziato a palesare. Sin da piccolo alla vista di colori molto forti e sgargianti si mostrava nervoso ed agitato, e i suoni delle percussioni, specie quelli improvvisi ed imprevisti, lo disturbavano non poco. La diagnosi, come una sentenza, era arrivata quando Filippo aveva due anni e mezzo, il giorno di santa Rita, Stefania lo ricordava bene.
Si era preparata leggendo molti articoli, perché alcuni segni e segnali li aveva colti anche lei. Filippo era bellissimo nel completino jeans e camiciola bianca, ma quei movimenti ripetuti, le braccia che si muovevano, seppur leggiadramente, a farfalla la avevano spaventata. Anche la pediatra era sembrata preoccupata da quei movimenti ripetuti, non si era pronunciata, e si era limitata a consigliarle il neuropsichiatra infantile, che avrebbe fatto indagini e dato un responso. Stefania aveva contenuto la sua ansia e quella dei suoi familiari, su tanti fronti, dispensando informazioni, ascoltando laconicamente le preoccupazioni dei nonni e delle prozie, non cautelandosi dai racconti sgraziati delle amiche, che raccontavano di sventure altrui con superficialità e scarsa tempestività.
Il suo terrore ed impotenza lei li viveva di sera, quando si documentava con fare certosino e maniacale sui blog, sui siti scientifici, fino a farsi bruciare gli occhi. Quando arrivò la diagnosi dell’equipe medica lei ormai sapeva tanto, più di quanto avrebbe dovuto, più di quanto avrebbe voluto. Il medico non lasciò dubbi: sindrome dello spettro autistico. Ogni singola parola che egli pronunciò Stefania ne conosceva e ne comprendeva il significato, complice mesi di studio indefesso. In tre quarti d’ora di auto, i più silenziosi che Gianluca, marito e padre sorpreso, ricordi, Stefania non proferì parola, sul retro appoggiata, con i suoi capelli biondo cenere avvolti in uno chignon semplice ed elegante, al sediolino bimbi di Filippo che riposava. Con il passare delle settimane consapevolezza e lacrime fecero la loro comparsa e divennero sempre più pregnanti; con il passare dei mesi accanto alle paure crebbero le risorse di quei due genitori, spiazzati dall’angoscia per quanto era accaduto, e dall’incomprensione del perché fosse successo proprio a loro. La paura cedette il passo all’azione e poco dopo la casa fu bonificata. Sulle mura di ogni stanza che Filippo frequentava comparvero colori tenui e tranquillizzanti. Stefania tolse ogni soprammobile e dalle mensole furono fatti sparire tre anni di peluche. Ogni lampadario e luce al neon fu sostituito da abat jour e luci soffuse; a Lia fu chiesto di giocare con la play station nei momenti in cui Filippo non fosse in casa. Per anni un carillon, regalo della nonna Lella, fu la colonna sonora dei pomeriggi della famiglia al rientro di Filippo dal centro terapico. Alcuni odori tra i vicoli della piccola Assisi dell’Irpinia richiamarono alla memoria di Stefania, quei profumi della cucina in cui Filippo trascorse e trascorre tutt’ora interi pomeriggi tra terapie fisiche, terapie occupazionali e tempo libero. Le stradine di Rocca San Felice erano invase dall’odore intenso dei peperoni quagliettani, i cosiddetti papazzi, e dai fagioli; ma ciò che rimandò indietro il cuore e i ricordi di mamma Stefania furono gli aromi delle zuppe di farro, legumi ed orzo saraceno, una delle specialità della cuoca del centro diurno che frequentava Filippo. Chissà se durante quella gita Filippo ricordava; chissà se Filippo nel suo guscio apparentemente profondo e inarrivabile riconosceva quei profumi e fosse capace di associarli nella sua mente ai tanti momenti di allenamento e trattamenti, trascorsi nel centro di terapia, come stava facendo la sua mamma.
Chissà se c’era un mondo in cui questi bambini vedono e vivono sentimenti e sensazioni che a noi adulti, cosiddetti sani, sono preclusi e sbarrati. Mortalità e straordinarietà, due immagini della stessa vita nei bambini speciali come Filippo, nelle famiglie trasformate come quella di Stefania e Gianluca, nelle vite di chi viene in contatto con loro e le loro cicatrici, che con gli anni restano lì in tutta la loro evidenza e che, inspiegabilmente per noi adulti non colpiti finiscono con diventare bellezza e ammirazione.
Le lacrime si trasformano in forza nelle braccia che aiutano nella deambulazione; la paura si muta in istanti presenti vissuti intensamente, come se ognuno di essi fosse l’ultimo, e per questo i più preziosi di sempre. Lo sconforto e la solitudine cedono il passo alle piccole grandi dosi di ottimismo che fanno vivere ogni giorno come un momento di gratitudine, come se non ci fosse un domani. La progettualità, una delle cicatrici più sofferte, cede il posto ad altri voleri, in un disegno più grande dell’individualità e del personale universo di ognuno.
Il centro, in questo, ha il suo piccolo merito, aver concesso uno spazio protetto ai bambini e alle bambine che in quelle stanze diventano giovani uomini e donne, e uno spazio confidenziale dove i familiari condividono occasioni per scoprire e costruire nuove risorse, quelle indispensabili a mantenere i legami in famiglia, e ad amare i loro figli nella maniera in cui essi possono decifrare. Ed è stato anche grazie al supporto degli anni di terapia che Filippo oggi riesce a camminare tra le strade di Rocca San felice, nel giorno della XXIV festa medievale, nelle prime ore della festa, quando le bancherelle si sono appena accaparrate i loro spazi, gli stand delle bibite iniziano ad offrire i primi assaggi e anche i figuranti iniziano a scalpellare, coniare, sferruzzare, con la riproposizione dei mestieri e degli utensili antichi. In questa parata di fragranze, bellezze architettoniche, scorci paesaggistici, Filippo si blocca, arresta il suo passo incurante che la sorella sia avanti, inconsapevole che sua madre sia accanto a lui, fisso con lo sguardo sullo scintillio di luce di una lampada ad olio di una taverna; e di lì non si muove più.
Lo capisce e lo sa Stefania che ha visto più volte il succedersi di azioni bloccate inaspettatamente e improvvisamente senza spiegazioni, da parte di quel figlio così misterioso ed amato; ma quell’immagine del suo bellissimo Filippo che mira una lampada antica è così poetica e surreale che anche lei si ferma volontariamente estasiata.
La gita a Rocca San Felice è finita, non ha rispettato l’itinerario previsto e programmato, ma del resto come Filippo ha ben insegnato a questi genitori, senza intervalli, la vita è caducità delle cose, dei luoghi, delle persone ed anche dei programmi che gli uomini ingenuamente si fanno senza troppa coscienza di come l’universo proceda.
Filippo come Giapeto, il titano più antico tra gli antenati del genere umano, sa che provare nostalgia di cosa sarebbe potuto essere e che non è stato, è poca cosa di fronte al mistero e all’infinito, e che l’uomo con la sua intelligenza e il suo desiderio di governare, riesce appena ad accarezzare.
Se gli eventi fossero potuti andare in un modo diverso ci sarebbero andati e nei luoghi della mente e del cuore la sofferenza può generare bellezza.

io sono Giapeto
Storia di Lucia
VIRGINIA WOOLF
Non devono aver paura del buio che inabissa le cose, perché quel buio libera una moltitudine di tesori. Quel buio che loro, libere, scarmigliate e fiere, conoscono come nessun uomo saprà mai.
Storia
di
Lucia

È un momento particolare. Non sai che domande farti e che risposte darti. Ma poi è lei a suggerirti le domande, quelle giuste. E a darti tutte le risposte. Ed è così da anni.
Lucia, così decidemmo di chiamarla quando per la prima volta i nostri occhi incrociarono i suoi, doveva chiamarsi Delia come la nonna materna, scomparsa solo un anno prima,
ma poi decidemmo per Lucia.
Quando al sesto mese ci dissero che sarebbe nata una bambina speciale, fu un colpo. A un tratto non eravamo tanto sicuri che noi fossimo altrettanto speciali.
All’altezza di esser speciali almeno per lei.
I giorni non passavano, le notti insonni, lunghe e immobili.
Le angosce, insopportabili.
E poi un’illuminazione: come un fascio di luce che ti abbaglia, intenso e deciso.
Lei sarebbe stata la nostra Lucia, in onore della Santa protettrice dei ciechi.
È ciechi ci sentivamo. Incapaci di credere che ce l’avremmo fatta. Increduli. Affannati.
Lei però, Lucia ci avrebbe guidato. Ci avrebbe dato la forza di veder oltre, oltre il possibile.
Improbabile forse, ma non impossibile.
Lucia vive ogni aspetto della vita con incontenibile emozione, i suoi sentimenti sono sempre più intensi di quello che noi crediamo lecito o dovuto; stringe rapporti interpersonali con chiunque le offra da parlare, con chiunque appaia ai suoi occhi una bella persona, e sono in tanti. È stata capace di scoprire bellezza e sprigionare resilienza anche tra le corsie dell’ospedale, cui ci siamo rivolti impauriti, ma consapevoli, per correggere il suo difetto del canale atrio-ventricolare. Su una parete dell’ospedale che a Lucia è sempre piaciuta molto, perché accoglieva e accoglie tuttora, le macchie colorate con la pittura a dita dei bambini ricoverati, leggevamo più volte al giorno una citazione, non mi sovviene più di chi: non vediamo le cose per come sono, ma le vediamo per come siamo. Quella frase letta passivamente per ore e giorni sapemmo interpretarla nella nostra vita solo molti anni dopo, spolverando tra i ricordi e le istantanee di cui Lucia è protagonista; la verità che ogni genitore scopre nella fatica e nelle lacrime, ovvero, che i bambini danno agli adulti forza nella fragilità, equilibrio nelle tempeste, coraggio nel terrore della perdita, pace nell’ineluttabilità degli eventi.
Il suo essere se stessa con l’unicità che la energizza tutta, ci ha educati col tempo a lottare con energia positiva e sguardo lucido; laddove noi vedevamo solo camici bianchi e stanze come profondi buchi neri insostenibili e terrorizzanti, spaventati dall’idea di altre operazioni e di ennesimi controlli, a lei riusciva ciò che per noi allora era impensabile, il non sentirsi sola, e al contempo il non farci sentire abbandonati e perseguitati dalla vita. Con le sue corse sui cavallucci a rotelle, messi a disposizioni dall’ospedale e con i clown-terapeuti instancabili lettori di quella favola con le avventure della scimmietta coraggiosa, noi ci aggrappammo e prendemmo in prestito la qualità del suo sguardo, fino a quando non fossimo stati noi capaci di essere, solo molti anni dopo, come lei, coraggiosa e risoluta, container di leggerezza e gentilezza per chi ci è accanto.
Lucia ha mantenuto la sua promessa.
Giorno per giorno ci ha restituito la vista, sorprendendo i nostri occhi.
Sorprendendoci sempre più forte.
Con il primo Mamma gridato quasi a voler difendere il suo gelato al pistacchio di cui è sempre stata ghiotta.
Con i primi passi, correndo verso di noi spinta dalla sabbia bruciante delle nostre estati sicule, nella splendida Siracusa, terra nativa della Santa nelle cui mani avevamo riposto tutte le nostre paure.
Lucia ha mantenuto la sua promessa. Sorprendendoci sempre più forte.
Con i lacrimoni del suo primo, forse, litigio con Martina la sua compagna di giochi all’asilo, e i suoi fiumi di lacrime più torridi delle sue scroscianti risate, con cui ha sempre conquistato tutti.
Ci ha sorpreso sempre Lucia, che ci ha permesso di restare orfani di quella cieca ostinazione a controllare tutto, a governare tutto; a imbrigliare tutto.
Ha liberato le catene delle parole, sciolto le briglie delle emozioni, scoperchiato i più segreti pensieri.
Ci ha permesso di dimenticare il nostro vano interrogarci, le risposte mancate, incuriosendoci e distraendoci con nuovi perché.
Lucia è lei. Ed è così.
Lucia oggi ha un fidanzato. Matteo che sembra averle riempito lo sguardo, alla cui foce ci siamo sempre abbeverati noi, afflitti da una sete implacabile.
Dondolano in giardino mentre noi da lontano li guardiamo, cogliendo la magia delle mille lingue dell’amore. Ed è il loro amore a farci rotolare indietro di ventisette anni da quando innamorati e folli ci abbracciamo, dopo aver scoperto di essere in attesa di quel figlio tanto desiderato.
Un flashback potente nella memoria che con un balzo al cuore dopo ventisette anni, in un nano secondo, ci restituisce il senso di tutto questo.
Quando un senso, disperati nella nostra grettezza non eravamo capaci di trovarlo, ci sarebbe bastata questa immagine, delle gambe penzolanti sul dondolo in giardino, di due giovani innamorati che si scambiano tenere promesse d’amore.
Nella buia disperazione di quella notte di ventisette anni fa, ci sarebbe bastato questo.
Ci sarebbe bastato immaginarla cosi: felice!
Oggi Lucia è così: semplicemente felice.
Lavora con il suo instancabile sorriso, proprio accanto al suo Mattia, che ha conosciuto servendo il pranzo dietro il bancone della mensa. In realtà si conoscevano già; quasi dieci anni insieme al centro diurno, dove, come nella maggior parte delle storie d’amore al loro inizio, non si sopportavano per nulla. Lei intenta a sperimentarsi sempre in nuovi giochi con i compagni, presa dal laboratorio teatrale in cui divertirsi ad indossare delle maschere, sentirsi libera di essere qualcun altro almeno per un giorno. Lui, più riservato.
In compagnia dei suoi immancabili colori, specie quegli acquarello con cui era solito diluire le emozioni della vita.
Centinaia gli sguardi che Lucia incrocia ogni giorno e che riempie con il suo scintillante occhio magnetico ricolmo di vita. Sembra avere quelle misteriose doti taumaturgiche a cui i più spesso non credono; sembra essere capace di guarirti con un sorriso. Le sue parole risuonano forti e chiare come le campane la domenica richiamando i fedeli alla preghiera: Buongiorno!, dice, oggi abbiamo una profumatissima pasta e lenticchie!
Ma se vuoi un consiglio la lasagna è squisita. E ancora: oggi non la prendi la frutta?
Fa bene, è ricca di vitamine, e con questo caldo è anche dissetante. È felice Lucia, piena di energia e di voglia di vivere; e ha sempre un’opinione su tutto.
Come Teia, nella mitologia greca, sorella e moglie di Iperione, madre di Elio (dio del sole), Selene (dea della luna) ed Eos (dea dell’aurora), Lucia pare proprio aver introiettato tutte le forze luminose dell’universo, come sembra suggerire l’appellativo originario della titanide stessa: Eurifessa, usato negli antichi scritti per accentuarne magnificenza e splendore. Lucia come Teia invocata nell’antichità come dea dai molteplici nomi, è una musa ispiratrice, la luce che splende da lontano, come veniva cantata nei miti pre-ellenici. Lucia, come Teia dea della vista, possiede un potente e magmatico raggio emesso dagli occhi, che è stato capace di illuminare le vite di molti, ma di certo, in primis di Clara e Andrea, il cui sguardo smarrito ritrovò finalmente la strada perduta, in quel lontano 13 dicembre di 27 anni fa.

io sono Teia
Storia di Tommaso
PABLO NERUDA
Amo ciò che di tenace ancora sopravvive nei miei occhi, nelle mie camere abbandonate dove abita la luna, e ragni di mia proprietà, e distruzioni che mi sono care, adoro il mio essere perduto, la mia sostanza imperfetta.
Storia
di
Tommaso
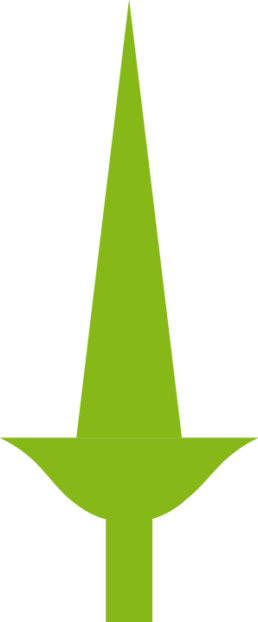
L’arena stracolma. Il palco al centro. Centinaia di ballerini.
Le note, i costumi, i colori, le luci abbaglianti. E lui, il suo mito, il suo cantante preferito proprio lì dirimpetto a lui.
Non era tanto lontano e finalmente col pass backstage l’avrebbe abbracciato. Forse uno scatto con la sua polaroid istantanea e un autografo sul suo CD, il suo primo in quei lontani anni ‘80, quando era un lusso averlo.
È passato poco più di un anno da quel giorno. Archi e fiati, che vestono i brani di sonorità e arrangiamenti sorprendenti; ben venticinque artisti di altre discipline, a dar vita ad una epocale prima volta musicale, artistica e scenografica. Non solo musica, ma un vero spettacolo a 360°, con coreografie, scenografie mobili e movimenti innovativi; tutti gli stili del mondo, dalla danza, al teatro, alla mimica. Tutto lì, tutto per lui, in quel 15 settembre 2018. Tommaso non era mai stato ad un concerto. Era la sua prima volta.
Per i suoi quarant’anni i genitori, Anna e Salvatore, ancora giovanissimi, appena sessantenni, avevano voluto coronare il suo sogno. E di lì, i biglietti, il viaggio in treno, una visita al balcone di Giulietta e poi via all’Arena. Tensione mista a stupore. Attesa, trepidazione e sudore, misto a emozione. Tommaso, le sapeva tutte a memoria.
Anni e anni ad ascoltarlo: quella sua maglietta fina, che gli ricordava il sapore dell’estate, e tu come stai, che pensava sempre fosse una domanda per lui.
Ora era proprio lì, a festeggiare i cinquant’anni della sua carriera. E i genitori alle sue spalle emozionati e raggianti erano ormai con lui dietro le quinte. Qualche scatto assieme, un abbraccio fragoroso e quell’autografo sul singolo di Strada facendo, che ormai dorme con Tommaso sotto il suo cuscino da quel giorno, quasi a conservare il calore di quel ricordo. E di ricordi Tommaso ne ha tanti, quando da bambino scorrazzava per i vicoli di Scala, dove era nato e cresciuto, quando da ragazzino viveva le estati al mare, giù ad Atrani, in quell’angolo di paradiso, alle spalle dei monti Lattari, quando giovanotto si riscaldava negli inverni freddi, ma che non spaventano chi vive tra i sentieri della Divina, dove un arcobaleno sbuca sempre, tra i limoneti impigriti dalla pioggia, ed il grigio cupo si fonde con il blu intenso del mare.
Di ricordi Tommaso ne aveva proprio tanti in quei quarant’anni, cresciuto felice e coccolato da due genitori affettuosi, spesso apprensivi. Tommaso non conosceva il rumoroso tran tran dei bus, sempre accompagnato dai suoi, anche quando quotidianamente iniziò a frequentare il Centro sin da piccolo. Non ricordava con esattezza i primi giorni lì, ma aveva memorizzato le fattezze di tanti uomini e donne tra le figure professionali, che avevano accompagnato lui e altri bambini come lui: il foniatra, il logopedista, il terapista della neuro, il fisiatra, l’operatore socio sanitario, ma il suo preferito era sempre stato il giovane che era solito portare a lui e i suoi amici il pranzo; non rimaneva mai tanto, giusto il tempo di scaricare gli scaldavivande, ma aveva un sorriso grande e una strofa, che cantava ogni giorno quando entrava dalla porta-finestra blu: il mattone vuole esser casa, un mattino divenire chiesa. Un bambino speciale, insomma, estremamente consapevole di esserlo. Tommaso amava presentarsi e non era per nulla timido. Era solito annunciarsi dicendo: sono Tommaso. Ho tutte le rotelle, ma qualcuna è più veloce, e altre sono più lente. Ma non aver paura di me.
Facciamo amicizia? Cordiale ed estroverso, sempre sorridente Tommaso, aveva un leggero ritardo psicomotorio, eredità infausta di un parto travagliato. Ma travagliata non è stata la sua vita, sempre al centro dei pensieri di Anna e Salvatore che gli avevano dato tutto, davvero tutto quello che avevano, con tutto l’amore strabordante, di cui erano stati capaci. Tommaso frequentava il Centro da anni tra laboratori ludico-ricreativi e piani educativi multidisciplinari. Aveva fatto amicizia con l’inserviente del centro, un indiano di ventisei anni, che gli aveva insegnato alcuni modi di dire in inglese, e durante gli anni di “lezione” con Mantej, ne aveva imparati tanti a memoria e in tre decenni li aveva imparati sempre meglio. Divenuto giovanotto durante l’estate affollata di turisti si era guadagnato il soprannome di Tom English, da parte dei vecchietti davanti al bar, che lo avevano visto crescere e pronunciavano il suo soprannome con quell’inconfondibile cadenza partenopea: Tomm Inglísc! Era così persuasivo e comunicativo che riusciva a convincere i turisti, attratti dalle classiche mete costiere, Amalfi, Sorrento, Positano, a fare una tappa al suo paese, Scala, un piccolo Comune a 400 metri sul mare, Paese di 1500 abitanti, tra marinai e artigiani, sin dall’età della Repubblica Marinara. Così inconsapevole e spontaneo Tommaso divenne presto il primo ambasciatore della sua città, tanto da guadagnarsi, il Premio Cicerone dell’anno, che il Sindaco volle istituire lanciando il progetto di marketing territoriale, con l’invito a prendere esempio da Tommaso e recuperare turisti in visita nel borgo di Scala. I ricordi sono tanti, dagli effetti e affetti speciali. Ma tanti ancora, Tommaso è pronto ad archiviarli.
Ora non fa più avanti e indietro dal Centro di Tramonti, ora Tommaso lavora; è il responsabile del trasporto pasti alla mensa della scuola del suo paese, la stessa dove andava da ragazzino. E questo lo inorgoglisce; lo rende persino originale agli occhi di chi gli dedica uno sguardo distratto, quando lo incontra intento nel suo lavoro, attraente agli occhi di quei genitori, che sperimentano come Anna e Salvatore, sentimenti di confusione misti a tenerezza, forte agli occhi di chi lo ama. Quella stessa forza e potenza che caratterizza Crio, figlio di Urano, il Cielo e di Gea, la Terra, rappresentato come
il pilastro a protezione del Sud, posto lì da suo padre a difesa di uno dei quattro angoli del mondo. Mai domi, mai rassegnati ai difetti e alle fatiche del mondo, Crio e Tommaso vivono la loro quotidianità in difesa della vita quella vissuta, non in attesa, quella attiva
e partecipata, non passiva ed estranea. Tommaso è stato educato all’amore e vigore da Anna e Salvatore, genitori di frontiera, che hanno imparato con il loro bambino e grazie al loro bambino che tutte le famiglie, prima di abitare una casa fatta di mattoni, abitano un’altra casa, quella degli affetti e del coraggio. Grazie alla potenza di pensieri ed emozioni, grazie a preparazione e supporto Salvatore, Anna e Tommaso hanno fatto della paura del domani il monito per vivere con fortezza gli istanti piccoli e preziosi, irripetibili
e perfezionabili, che la vita regala a chi li sa scorgere. Tommaso va avanti sulle note e sui testi delle sue canzoni del cuore, e pensa che strada facendo, troverà le risposte, anche se forse non si è ancora fatto tutte le domande. E sa, come gli hanno insegnato i suoi Annarell’ e Sasà, come ama appellare i suoi genitori, e come gli ricordano i versi del suo amato cantante: Sei tu che spingi avanti il cuore ed il lavoro duro di essere uomo e non sapere cosa sarà il futuro. Sei tu nel tempo che ci fa più grandi e soli in mezzo al mondo con l’ansia di cercare insieme un bene più profondo. Perché la vita è adesso!
È adesso, per Tommaso che ha creduto in questa fantastica storia che si chiama vita e che ha un solo tempo: adesso. Un adesso, un istante che ci ricorda come direbbe Tommaso, Tomm Inglísh: Never give up, non mollare mai.

io sono Crio
Template news
PAULO COELHO
Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa, e a pretendere con ogni sua forza quello che desidera.
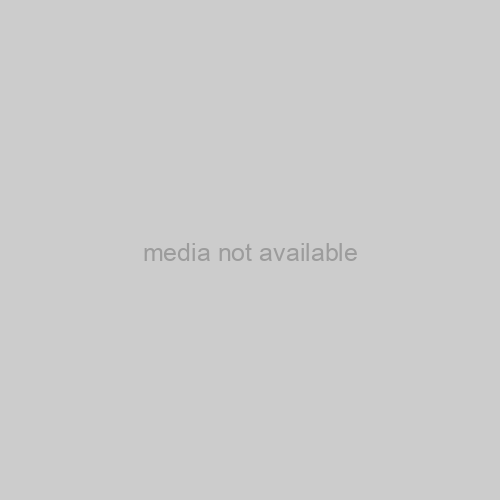
Le foglie cadono lente.
Come ad una ad una da un contagocce.
Scompigliate come i capelli al vento, si uniscono promiscue.
Danzano lievi e sembra quasi sentirsi la dolce melodia diffusa che si leva dall’asfalto, come a formare una nuvola. Sfidano la forza di gravità e si elevano al cielo.
Continuano a cadere lente queste foglie, che inneggiano all’arrivo di una nuova stagione.
Un’altra estate è finita. E l’inverno arriverà. Ad annunciarlo malinconico è il continuo fruscio del vento.
I rami secchi sottili e fragili, tintinnano sui vetri, ritmando un nuovo sound.
Sono degli occhi nero catrame che assistono dietro quella finestra opaca a questa nuova magia della natura.
Sono gli occhi profondi di Luna.
Polverosi come le strade su cui continuano a cadere le foglie.
Luna ha undici anni. E i suoi occhi fragili hanno visto solo undici primavere.
Ma sono abbastanza per lei.
Quegli occhi stanchi hanno già visto tanto; o troppo, o ancora troppo poco.
Luna vive lì da sempre. Ha tanti amici. Studia, gioca, ama leggere e immaginare mondi fantastici.
Adora le storie di principesse. Tutte. Tutte quante.
Rinchiuse nelle torri, prede di mostruose creature, rapite da streghe paurose, sequestrate da gnomi malefici. Le ama tutte. Perché come loro, sa che prima o poi sarà salvata.
Ma salvata da cosa?
Luna ha dei fantastici compagni di scuola e di gioco, premurose maestre; ha anche Giulia, la sua amichetta del cuore che divide con Alessia, la sorellina più piccola di Giulia. Luna vuole essere salvata. Non sa bene da chi, o forse non le importa, ma sa da cosa.
Da quel vuoto che avanza quando il Natale è alle porte. Da quell’ansia che le aggroviglia lo stomaco in prossimità del suo compleanno, da quell’angoscia che le irrompe nel petto con l’avanzare dell’estate.
Luna vuole essere salvata da tutto questo. O meglio da lei stessa in tutto questo.
Luna non è sola, ma si sente sola. Luna è orfana.
Lo è anche Giulia. Lo è anche Alessia.
Ma proprio ieri le ha viste andar via.
C’erano due occhi neri come la pece, ruvidi come il carbone, pesanti come dinamite dietro quella finestra.
Sullo sfondo di quel cielo autunnale, tra le foglie che ballavano tra gli alberi, c’erano Giulia e Alessia. Ma non erano sole. Un lungo cappotto bianco e una giacca chiara in lontananza. I colori si perdevano ad ogni passo, ma le mani si intrecciavano tutte tra di loro e benché lontane, lei, Luna, le vedeva.
Poteva scorgere gli infinitesimali movimenti delle falangi che si stringevano.
Le sembrava di sentirne il calore, quasi il sudore, la presa forte e sicura, decisa; come decise erano state le scelte di Carla e Paolo che, dopo un paio di settimane d’estate insieme alle piccole, e tanti altri fine settimana a seguire, avevano scelto di poter stringere per sempre quelle mani, quelle di Giulia e Alessia.
Luna era lì durante il loro incedere lento verso l’auto, una berlina grigio scuro, la stessa che in un attimo vide andar via. Mentre lei rinchiusa nella sua torre continuava a sperare di esser salvata.
Un sorriso irruppe a spezzare quella scena dolorosa, una delle tante che in undici anni avevano ingoiato quegli occhioni grandi. Quel sorriso era il suo. Proprio il suo.
Il tintinnio dei rami sui vetri, e quel vento crescente che lo generava faceva da sottofondo al suo valzer delle emozioni che iniziò ad accompagnare accennando dei passi.
Il copriletto in un balzo divenne mantello.
Le bacchette dello xilofono si fecero scettro e Luna iniziò a danzare, a danzare sempre più forte fino a capitolare sul letto, dove si abbandonò ad un morbido abbraccio col suo cavaliere, quel cuscino la cui federa ingrigita, a righe bianche e blu, iniziò a tingersi
di lacrime.
Luna piangeva e rideva. Sperava e soffriva. Gridava di quelle urla sorde dell’anima che sfidano l’ululare del vento, sempre più copioso sui vetri. Luna era lì, mentre un’altra notte scendeva e in attesa di potersi perdere in un vero abbraccio, si perse tra le braccia
di Morfeo.
Oggi Luna ha cambiato città da poco.
Adorava leggere e si è iscritta a Lettere Antiche.
Sta preparando Greco e intanto continua ad allenarsi. Fa ginnastica ritmica. Il mese prossimo ha gli esami per diventare insegnante. È dura. Ma lei le sfide le conosce.
Ne conosce l’odore della paura. Il suono della sconfitta. Ne conosce anche il sapore.
Lei la sua sfida l’ha vinta.
Da quella torre è uscita, grazie a Chiara e Marco che un giorno freddo di marzo le scaldarono il cuore e le strinsero quelle manine gelide e incredule.
Come Rea, spesso raffigurata nella mitologia trainata due leoni, così Luna, dalla titanica forza interiore, trainata da suoi due leoni, Chiara e Marco, scopre cosa vuol dire famiglia.
Personificazione delle forze della natura, dea della terra e degli animali, Rea dea dell’abbondanza, dea madre di tutti gli dei, sembra ispirare una delle principesse che facevano compagnia a Luna, durante l’infanzia. Luna sembra prendere a prestito proprio da Rea la sua instancabile forza vitale, quella stessa che la dea tirò fuori sperando fino all’ultimo di salvare suo figlio, come racconta il mito.
Una storia, quella di Luna, di straordinaria follia, quella stessa che spinge una coppia
a trovare la coraggiosa incoscienza per meritarsi un figlio. Un percorso non facile, fatto
di illusioni e delusioni, di angosce ed entusiasmi, di lacrime e di chi non smette
di asciugartele. Tante le coppie, giovani e meno giovani, che hanno intrapreso questa strada tortuosa, quella della genitorialità mancata, che finalmente riesce a diventare ritrovata. Una come tante, la storia di Chiara e Marco che, instancabili, scalano la torre per salvare Luna dai suoi fantasmi, per poi scoprire di essere stati loro ad essere salvati.
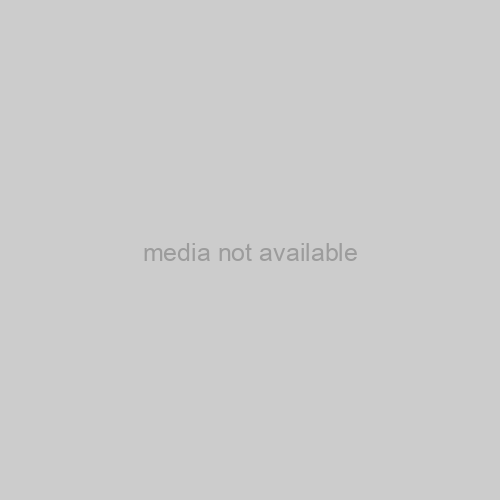
io sono Rea
Storia di Luna
PAULO COELHO
Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa, e a pretendere con ogni sua forza quello che desidera.
Storia
di
Luna
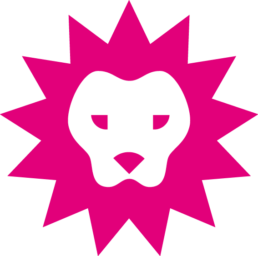
Le foglie cadono lente.
Come ad una ad una da un contagocce.
Scompigliate come i capelli al vento, si uniscono promiscue.
Danzano lievi e sembra quasi sentirsi la dolce melodia diffusa che si leva dall’asfalto, come a formare una nuvola. Sfidano la forza di gravità e si elevano al cielo.
Continuano a cadere lente queste foglie, che inneggiano all’arrivo di una nuova stagione.
Un’altra estate è finita. E l’inverno arriverà. Ad annunciarlo malinconico è il continuo fruscio del vento.
I rami secchi sottili e fragili, tintinnano sui vetri, ritmando un nuovo sound.
Sono degli occhi nero catrame che assistono dietro quella finestra opaca a questa nuova magia della natura.
Sono gli occhi profondi di Luna.
Polverosi come le strade su cui continuano a cadere le foglie.
Luna ha undici anni. E i suoi occhi fragili hanno visto solo undici primavere.
Ma sono abbastanza per lei.
Quegli occhi stanchi hanno già visto tanto; o troppo, o ancora troppo poco.
Luna vive lì da sempre. Ha tanti amici. Studia, gioca, ama leggere e immaginare mondi fantastici.
Adora le storie di principesse. Tutte. Tutte quante.
Rinchiuse nelle torri, prede di mostruose creature, rapite da streghe paurose, sequestrate da gnomi malefici. Le ama tutte. Perché come loro, sa che prima o poi sarà salvata.
Ma salvata da cosa?
Luna ha dei fantastici compagni di scuola e di gioco, premurose maestre; ha anche Giulia, la sua amichetta del cuore che divide con Alessia, la sorellina più piccola di Giulia. Luna vuole essere salvata. Non sa bene da chi, o forse non le importa, ma sa da cosa.
Da quel vuoto che avanza quando il Natale è alle porte. Da quell’ansia che le aggroviglia lo stomaco in prossimità del suo compleanno, da quell’angoscia che le irrompe nel petto con l’avanzare dell’estate.
Luna vuole essere salvata da tutto questo. O meglio da lei stessa in tutto questo.
Luna non è sola, ma si sente sola. Luna è orfana.
Lo è anche Giulia. Lo è anche Alessia.
Ma proprio ieri le ha viste andar via.
C’erano due occhi neri come la pece, ruvidi come il carbone, pesanti come dinamite dietro quella finestra.
Sullo sfondo di quel cielo autunnale, tra le foglie che ballavano tra gli alberi, c’erano Giulia e Alessia. Ma non erano sole. Un lungo cappotto bianco e una giacca chiara in lontananza. I colori si perdevano ad ogni passo, ma le mani si intrecciavano tutte tra di loro e benché lontane, lei, Luna, le vedeva.
Poteva scorgere gli infinitesimali movimenti delle falangi che si stringevano.
Le sembrava di sentirne il calore, quasi il sudore, la presa forte e sicura, decisa; come decise erano state le scelte di Carla e Paolo che, dopo un paio di settimane d’estate insieme alle piccole, e tanti altri fine settimana a seguire, avevano scelto di poter stringere per sempre quelle mani, quelle di Giulia e Alessia.
Luna era lì durante il loro incedere lento verso l’auto, una berlina grigio scuro, la stessa che in un attimo vide andar via. Mentre lei rinchiusa nella sua torre continuava a sperare di esser salvata.
Un sorriso irruppe a spezzare quella scena dolorosa, una delle tante che in undici anni avevano ingoiato quegli occhioni grandi. Quel sorriso era il suo. Proprio il suo.
Il tintinnio dei rami sui vetri, e quel vento crescente che lo generava faceva da sottofondo al suo valzer delle emozioni che iniziò ad accompagnare accennando dei passi.
Il copriletto in un balzo divenne mantello.
Le bacchette dello xilofono si fecero scettro e Luna iniziò a danzare, a danzare sempre più forte fino a capitolare sul letto, dove si abbandonò ad un morbido abbraccio col suo cavaliere, quel cuscino la cui federa ingrigita, a righe bianche e blu, iniziò a tingersi di lacrime.
Luna piangeva e rideva. Sperava e soffriva. Gridava di quelle urla sorde dell’anima che sfidano l’ululare del vento, sempre più copioso sui vetri. Luna era lì, mentre un’altra notte scendeva e in attesa di potersi perdere in un vero abbraccio, si perse tra le braccia di Morfeo.
Oggi Luna ha cambiato città da poco.
Adorava leggere e si è iscritta a Lettere Antiche.
Sta preparando Greco e intanto continua ad allenarsi. Fa ginnastica ritmica. Il mese prossimo ha gli esami per diventare insegnante. È dura. Ma lei le sfide le conosce.
Ne conosce l’odore della paura. Il suono della sconfitta. Ne conosce anche il sapore.
Lei la sua sfida l’ha vinta.
Da quella torre è uscita, grazie a Chiara e Marco che un giorno freddo di marzo le scaldarono il cuore e le strinsero quelle manine gelide e incredule.
Come Rea, spesso raffigurata nella mitologia trainata due leoni, così Luna, dalla titanica forza interiore, trainata da suoi due leoni, Chiara e Marco, scopre cosa vuol dire famiglia.
Personificazione delle forze della natura, dea della terra e degli animali, Rea dea dell’abbondanza, dea madre di tutti gli dei, sembra ispirare una delle principesse che facevano compagnia a Luna, durante l’infanzia. Luna sembra prendere a prestito proprio da Rea la sua instancabile forza vitale, quella stessa che la dea tirò fuori sperando fino all’ultimo di salvare suo figlio, come racconta il mito.
Una storia, quella di Luna, di straordinaria follia, quella stessa che spinge una coppia
a trovare la coraggiosa incoscienza per meritarsi un figlio. Un percorso non facile, fatto
di illusioni e delusioni, di angosce ed entusiasmi, di lacrime e di chi non smette
di asciugartele. Tante le coppie, giovani e meno giovani, che hanno intrapreso questa strada tortuosa, quella della genitorialità mancata, che finalmente riesce a diventare ritrovata. Una come tante, la storia di Chiara e Marco che, instancabili, scalano la torre per salvare Luna dai suoi fantasmi, per poi scoprire di essere stati loro ad essere salvati.
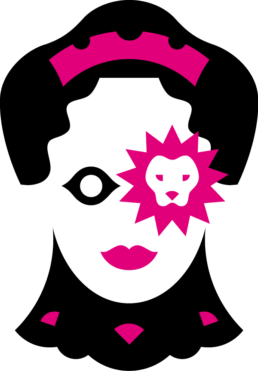
io sono Rea
Asili nido in Piemonte: il divario con le regioni del nord e le disparità interne
Essere adolescenti ai tempi del COVID-19
Che cos’è l’osservatorio povertà educativa
L’osservatorio sulla povertà educativa è curato in collaborazione tra Con i
bambini – impresa sociale e Fondazione openpolis nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
L’obiettivo è promuovere un dibattito informato sulla condizione dei minori in Italia, a partire dalle opportunità educative, culturali e sociali offerte, ed aiutare il decisore attraverso l’elaborazione di analisi e approfondimenti originali.